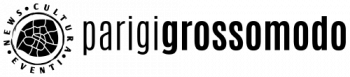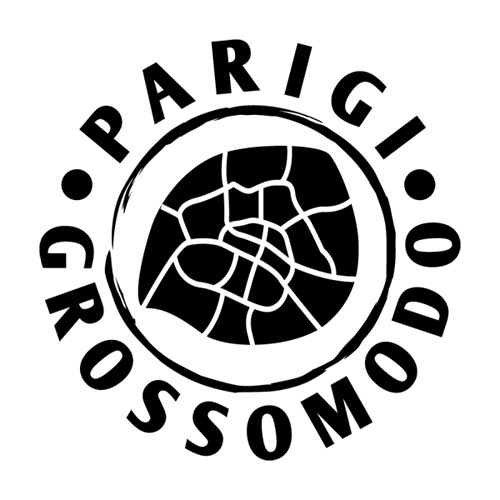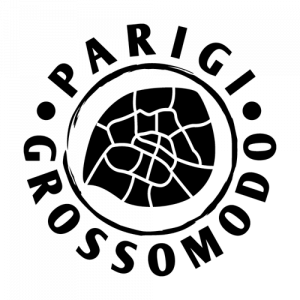Sono passati ormai quasi dieci giorni da quando Parigi ha subito il peggior attacco terroristico dai tempi della seconda Guerra Mondiale, e ancora non è facile trovare le parole per superare lo stupore, la rabbia, la paura, l’indignazione, il dolore – soprattutto il dolore. Non è facile mettere insieme i brandelli di pensiero che si sono succeduti nei giorni posteriori agli attentati, giorni confusi in cui si è vissuto sospesi a metà: da un lato la vita che cerca di riprendere il sopravvento, dall’altro la paura che non accenna a passare, il pensiero che torna continuamente alle vittime, la tristezza che pervade ogni cosa, il timore che non sarà più possibile vivere come prima.
Però una volta che le prime emozioni si sono dissipate, rimane – intatto, impellente – il bisogno di capire, di interrogarsi sul perché di questi attentati. Di trovare delle vere risposte a delle vere domande dopo il carosello delle manifestazioni di solidarietà, delle semplificazioni da tabloid e delle sperticate dichiarazioni d’amore alla Ville lumière della stampa nazionale e straniera.
Les français jihadistes
Venerdì 13 novembre almeno otto giovani, per la maggioranza di cittadinanza francese o belga, hanno imbracciato delle armi di guerra e hanno ucciso 130 persone, in gran parte loro coetanei. Bilal Hadfi, il più giovane dei terroristi, che si è fatto esplodere all’entrata dello Stade de France, aveva precisamente vent’anni: la prima domanda che mi sembra legittimo porsi è proprio quella del perché lo hanno fatto.
Questi giovani sono dei punti interrogativi che bussano alle porte delle nostre coscienze, sono delle pietre lanciate ai vetri del nostro quieto vivere. Cosa può spingere un giovane nato in Francia, cresciuto a pochi kilometri da una grande città, a convertirsi all’Islam jihadista su internet, a decidere di partire in Siria a combattere per il sogno di uno stato teocratico che occupi tutta la terra di Sham, e – in una tiepida sera di novembre – a indossare una cintura esplosiva o a prendere in mano un kalashnikov per andare a massacrare degli sconosciuti? In questi giorni chi ha cercato di capire le motivazioni alla base di questi atti inumani è stato spesso accusato di “giustificazionismo”. Niente può – ovviamente – giustificare degli assassini (perché di assassini si tratta, e non esiste nessuna giustificazione alle loro azioni). Ma cercare di capire non significa giustificare, cercare di capire è necessario, e sarebbe un grave errore scegliere di non farlo.
Nel 2014 David Thomson, reporter di France 24 e RFI specialista di Africa e Medio Oriente ha pubblicato un libro dal titolo Les français jihadistes, risultato di diversi mesi di inchiesta e di interviste a questi giovani francesi che avevano scelto di partire in Siria per combattere la loro guerra santa. Quello che emerge pagina dopo pagina è la ricerca di senso da parte di queste persone che – deluse da quello che la società offre loro – finiscono per trovarlo nella follia dell’estremismo religioso. Spesso appartengono alle famose seconde generazioni, e provengono da quelle banlieue additate come vivai di criminali e poi scandalosamente lasciate sole da uno Stato che deliberatamente sceglie di marginalizzare fasce intere di popolazione. Certo è terribile che questi giovani siano preda di criminali senza scrupoli, di reclutatori di carne da cannone (né più né meno), e che finiscano per farsi sedurre dalle sirene della violenza e della guerra. Ma la domanda più lacerante che dobbiamo porci è: quale alternativa gli ha proposto la nostra società? Quale alternativa gli abbiamo proposto?
Il fatto che dei giovani francesi siano pronti a morire e a uccidere, convinti da una fede traviata e violenta, è uno dei sintomi del fallimento della nostra società. Fallita perché lascia indietro i più poveri, i più soli, i diversi, permette che scivolino attraverso le pieghe del sistema, che finiscano dimenticati da tutti, senza altra via di scampo se non il rifugio identitario della religione: “On est nés entre deux cultures: en France, on nous appelle les enfants d’immigrés. Au Maroc, on nous appelle les enfants de l’étranger. On est une génération déracinée, sans repères.” Fallita perché le zone d’educazione prioritaria hanno come unico risultato quello di creare delle scuole ghetto, dove chi può farlo sceglie di non mandare i propri figli, e dove – invece di mandare i migliori insegnanti possibili – si mandano i professori neo-diplomati a farsi le ossa. Ma soprattutto fallita perché non ha offerto niente da sognare a questi giovani. Niente se non un televisore al plasma da mettere in salotto e un’automobile più potente. Niente.
Reagire agli attentati
Eppure, proprio davanti a questo fallimento ormai manifesto, la prima reazione – ben diffusa da giornali ed altri mezzi d’informazione – è stata quella di proclamare una sorta di orgoglio parigino, fatto di incitazioni a tornare a sbronzarsi ai bar, di prose strappalacrime che celebrano la joie de vivre à la française (il famoso commento di un lettore americano del New York Times ne è un esempio perfetto) o di bandiere tricolore di dubbio gusto. Parigi ancora contava i suoi morti quando la home page di Facebook si è trasformata in una vetrina di bandiere francesi.
Il messaggio che è passato è: non abbiate paura, combatteremo il terrorismo andando a bere nei bar, andando a cena al ristorante e facendo shopping per Natale alle Galeries Lafayette. In sintesi: consumando consumando consumando. Ingozzandoci di tutti i beni futili come se questo difendesse la nostra libertà. La nostra libertà di scegliere la marca di corn flakes al supermercato, naturalmente. Poiché ogni attacco porta con sé una chiusura identitaria, anche se inconscia, il risultato degli attentati del 13 novembre è quello di farci sentire in dovere di puntellare ideologicamente e materialmente lo status quo. E mentre noi difendiamo la libertà di consumare irrazionalmente, i nostri capi politici e militari massacrano altri civili a poche migliaia di kilometri dalle nostre città.
Ma non ne abbiamo abbastanza di morti? Non ci sono bastati quindici anni di pazza, insensata, “guerra al terrore” per renderci conto che stiamo soltanto creando un mondo più brutto e più cattivo dove fare crescere le generazioni future? Non è bastato il fallimento totale della politica americana post-11 settembre a farci capire che queste sono guerre che non si possono vincere? Non c’è stato neppure bisogno di dichiarare guerra al terrorismo, questa volta, perché in guerra ci siamo già da decenni. (Anche se i nostri governi ci hanno voluto far credere che si poteva fare la guerra per procura, con i droni e le bombe, falcidiando centinaia di migliaia di vite senza avere l’orrore a portata di vista… Beh, no – non si può.) In guerra contro un mostro che abbiamo creato noi e che continuiamo a finanziare noi, che ciechi davanti all’Apocalisse, come scriveva negli anni ‘50 Günther Anders, ci ostiniamo a rimanere (per esempio) schiavi del petrolio e dei combustibili fossili. Ora: provate a indovinare da cosa trae gran parte delle proprie risorse lo Stato Islamico…
Sia chiaro: il terrorismo va combattuto e vinto, e l’orrore che Parigi ha vissuto venerdì 13 è qualcosa di raccapricciante e barbaro, che non può essere giustificato in nessun modo. Ma forse lanciarsi in un’escalation di violenza non è la migliore soluzione immaginabile.
Un altro mondo è – ancora – possibile
Questa è quindi la risposta che abbiamo deciso di dare: bombe, patriottismo e difesa della società dei consumi di cui siamo diventati schiavi. Schiavi che altri schiavi uccidono, convinti di farlo per un’ideale, per una religione, mentre tutto questo accade per i soliti motivi per i quali si sono sempre fatte le guerre: potere, denaro, interessi geopolitici.
Eppure un’altra risposta è possibile. Un’altra risposta che non siano i bombardamenti, che non sia la difesa cieca di un assetto sociale e geopolitico destinato a crollare a causa della sua stessa iniquità. L’attentato dell’11 settembre 2001 non distrusse soltanto il senso di sicurezza che l’Occidente aveva fino a quel momento, ma tagliò le gambe anche ai movimenti no global e altermondisti che proprio in quegli anni stavano prendendo campo.
Caso vuole che tra una settimana inizi a Parigi la Conferenza Mondiale sul Clima, che ovviamente si svolgerà senza manifestazioni dell’opinione pubblica perché la Francia ha prolungato lo stato di urgenza. Potrebbe essere veramente l’occasione di un cambiamento. Ma ancora una volta, se sarà la paura a vincere, se non si ascolteranno tutte le voci, se il sistema si richiuderà su se stesso rifiutando ogni forma di critica, la possibilità di dimostrare che un altro mondo è possibile verrà di nuovo perduta.
Gloria Liccioli
In un articolo pubblicato sul numero di agosto 2015 de « Le Monde diplomatique » dal titolo Des brigadistes aux djihadistes, combattre à l’etranger il sociologo Laurent Bonelli faceva una riflessione sui conflitti che negli ultimi 150 anni avevano attirato l’entusiasmo e la partecipazione concreta di combattenti venuti dall’estero, persone, per lo più giovani, che, seppur non implicate direttamente nella guerra, avevano deciso di parteciparvi mossi da convinzioni ideologiche. Proponeva dunque quello che mi era apparso un parallelo sorprendente fra i volontari della guerra di Spagna e i djihadisti che oggi si uniscono all’armata di Daesh.
Ci ho pensato molto, dallo scorso venerdì 13 novembre. Bonelli ha ragione, le similitudini tra chi si arruolava per combattere Franco e chi oggi decide di integrare le fila dello Stato islamico sono molte: la giovane età; l’adesione a un ideale, espresso spesso, in un caso come nell’altro, in maniera abbastanza sommaria e vagamente naïve (l’autore, nell’articolo, cita degli esempi); il bisogno di appartenere a qualcosa, di provare l’elettrizzante sentimento di essere al centro delle cose, protagonisti della storia.
Intervistato da Olivier Toscer per il documentario “Djihad 2.0”, Alain Rodier, esperto antiterrorista ed ex DGSE (Direction générale de la sécurité exterieure), inserisce l’adesione di tanti giovani francesi alla djihad propagandata dallo Stato islamico all’interno di una rivolta generazionale. La stessa, insomma, che muoveva gli studenti del ‘68 a ribellarsi contro i genitori borghesi e qualcuno di noi a colorarsi i capelli o a stracciarsi i jeans.
Dounia Bouzar, del Centro di prevenzione contro le derive settarie legate all’Islam, nello stesso documentario racconta che l’unico punto in comune nei profili delle ragazze francesi reclutate dai cacciatori di teste dello Stato islamico era il desiderio di fare un mestiere altruista, impegnarsi nell’umanitario, cambiare il mondo.
Insomma, se di fronte al bisogno di fare qualcosa di grande, di lottare, confrontati al malessere di una vita miserabile/noiosa/non appagante, di fronte alla sacrosanta e liberatoria ribellione contro gli imposti valori parentali, al nobile e legittimo desiderio di un mondo più giusto, l’unica risposta che questi giovani europei trovano è Daesh, allora c’è qualcosa che non va.
Si è parlato di mancata integrazione, di ghettizzazione, problematiche che sicuramente c’entrano e sulle quali è doveroso soffermarsi, ma i futuri combattenti dello Stato islamico non provengono soltanto dalle “banlieues difficili”, il bacino di reclutamento si allarga ad altri ambienti sociali.
Viviamo nell’epoca della comunicazione, tutti abbiamo internet e dei telefoni cellulari, la televisione ci propone decine di canali che ci danno l’illusione della pluralità. Figli della Rivoluzione francese, nasciamo “liberi e uguali”, andiamo a scuola e forse anche all’università. Ci hanno detto che potevamo avere tutto e noi ci siamo dati da fare. Ora siamo precari, freelance, competitivi, solitari, oppressi dalla crisi e dall’austerità, siamo immigrati, rifugiati, siamo stressati e sfruttati, impauriti e infelici, incapaci di accorgerci che il malessere è comune e di individuarne i responsabili.
In Iran il presidente è formalmente eletto a suffragio universale, ma tutte le candidature devono passare al vaglio del Consiglio dei guardiani, religiosi nominati a loro volta dalla guida suprema. Nel quadro istituzionale delle nostre democrazie occidentali, ogni disaccordo è lecito, purché si rimanga all’interno di un discorso conforme al dogma del progresso, della crescita e del capitale.
La mia sensazione è che lo spazio politico della discussione, dell’alternativa e della dissidenza sia rimasto vuoto, o per lo meno svuotato di autorevolezza e credibilità.
Avremmo bisogno di ritrovarci, di confrontarci, di protestare e costruire. Per il momento non se ne parla, l’état d’urgence est déclaré.
Silvia Cher