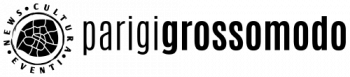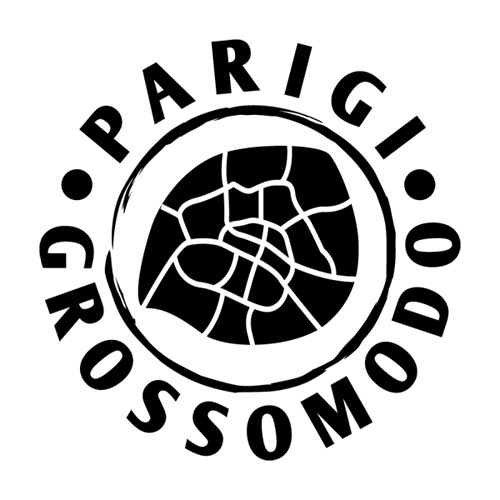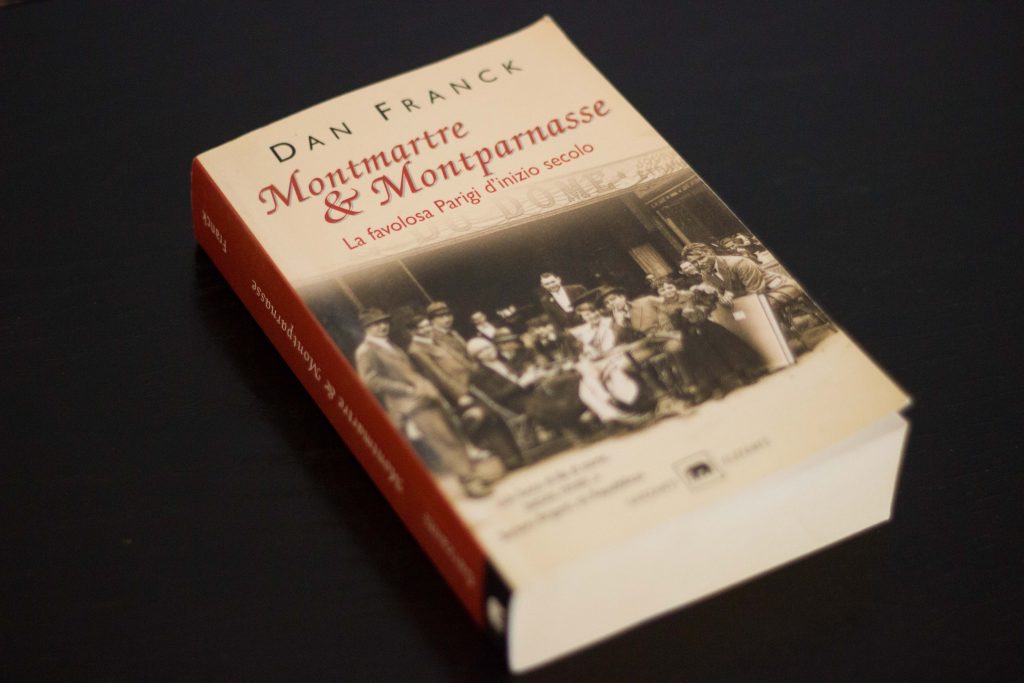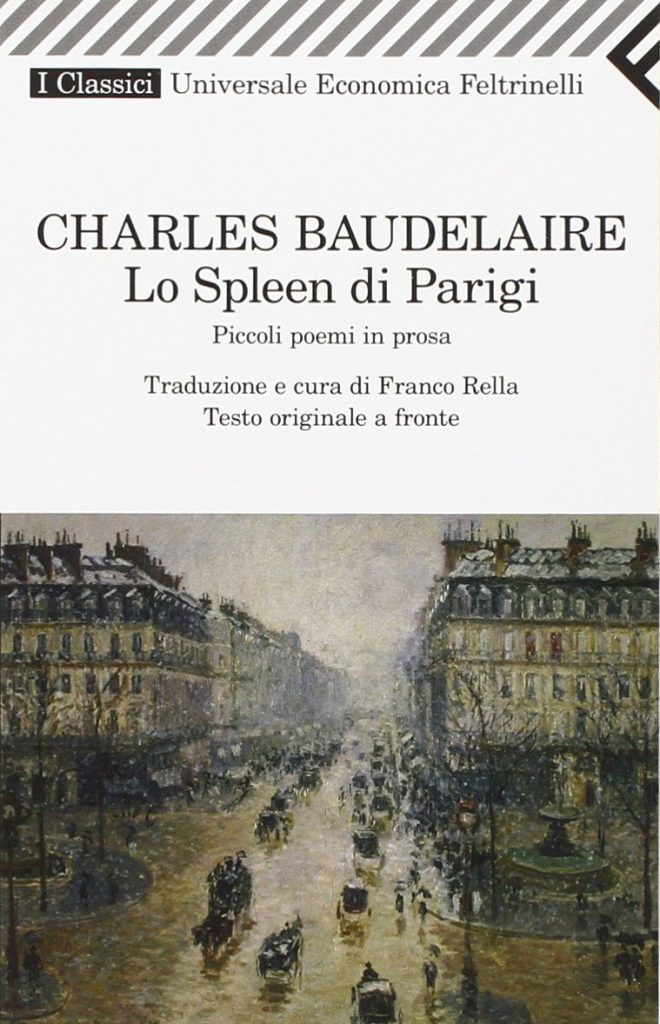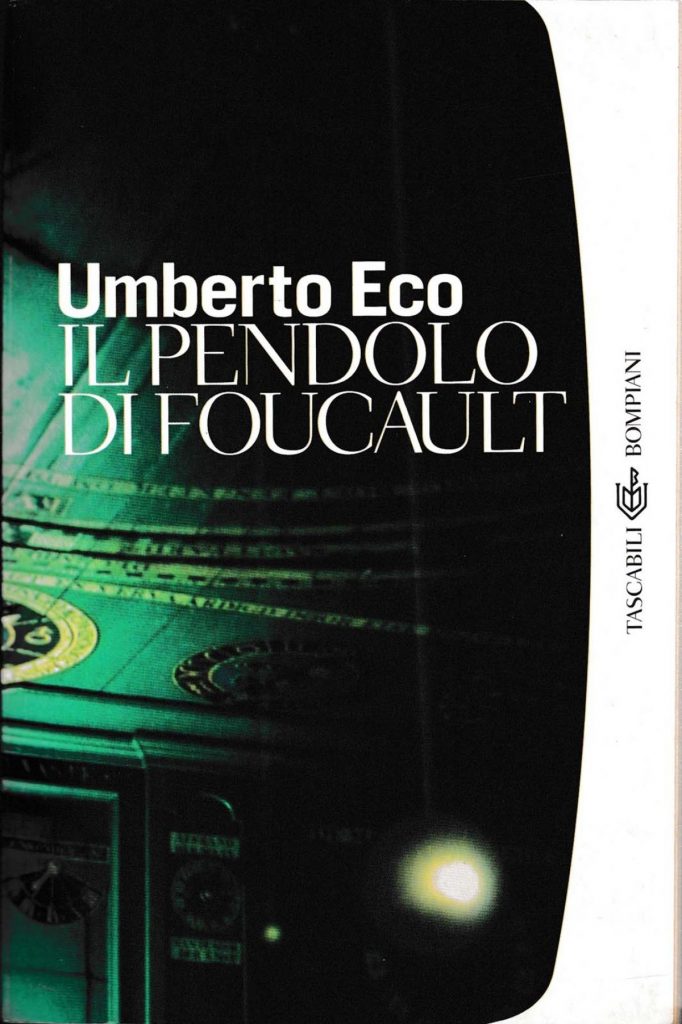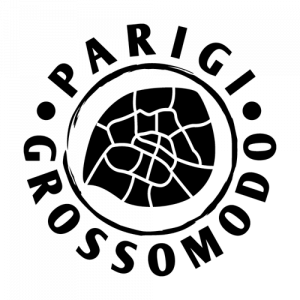In attesa del loro concerto il 2 novembre alla Bellevilloise, noi di Parigi Grossomodo abbiamo intervistato Zulù dei 99 Posse e Franco D’Aniello dei Modena City Ramblers. Ci hanno parlato del loro nuovo tour, ma anche di vecchie canzoni, di migrazioni e “Resistenza globale”.
Parigi Grossomodo: Come nasce questa collaborazione?
Franco D’Aniello (MCR): Nasce un po’ così, con un’agenzia con la quale abbiamo già lavorato molto che ci ha detto “Ma se facessimo un bel tour di qualche data nelle capitali europee con i 99Posse voi come la vedreste?” E noi abbiamo risposto, semplicemente: “Noi la vedremmo molto bene!”
Sarà un’avventura per noi: con loro non abbiamo mai fatto niente, ma essendo uno dei gruppi storici della musica alternativa italiana, penso che ci siano i presupposti per realizzare davvero un bel progetto. Noi ci diventiremo di sicuro, e anche il pubblico che, speriamo, non sarà solo italiano! Penso che anche per il pubblico straniero sarà una bella occasione per vedere due dei gruppi storici di un certo tipo di musica italiana.
Zulù (99 Posse): Con i Modena c’è sicuramente una fortissima contiguità di pubblico. Anche se i generi che facciamo e gli ambienti da cui proveniamo sono molto diversi, l’impronta fortemente identitaria è presente in entrambi i gruppi. I nostri concerti, come i loro, sono un momento in cui un certo tipo di persone si riunisce per contarsi, per vivere un’esperienza di socialità, che va al di là di quello che accade sul palco. Del resto siamo in un momento storico in cui, secondo noi, c’è bisogno di soffermarsi sulle cose che si hanno in comune con gli altri, piuttosto che sulle differenze. E poi, pur avendo entrambi una storia ultraventennale, non ci era mai capitato di fare qualcosa insieme, e visto che questa volta ce ne è stata offerta l’opportunità, abbiamo accettato con grande entusiasmo.
PG: È la vostra prima volta a Parigi?
F: No, abbiamo già suonato un paio di volte a Parigi: la prima volta abbiamo suonato una chiatta sulla Senna, con un palco piccolissimo, il pubblico che scendeva dalle scalette in una specie di antro dei nani… Un’atmosfera veramente un po’ surreale. La seconda volta è stato un concerto più “tradizionale” in un club, ma in entrambi i casi si è trattato di due concerti molto belli. Parigi è una città che ci piace molto: non è facile inserirsi per gli italiani, ma venirci a suonare è sempre una bella soddisfazione.
PG: Perché un tour europeo?
Z: In realtà l’idea è partita dal promoter che ha organizzato il tour. E’ stato lui a proporci di partire dall’Europa e noi siamo stati contenti, perché, a parte qualche data a Londra, una a Madrid e Barcellona, non siamo un gruppo abituato a suonare all’estero. Già il fatto che io lo chiami “estero”, testimonia del fatto che sono vecchio, perché ormai viviamo un mondo in cui l’estero non esiste più. (ride) In questa Europa unita, sono moltissimi gli italiani che si spostano, che decidono di andare a vivere in un altro paese, in maniera definitiva o meno. Per cui noi, come gruppo musicale, ci siamo resi conto che era assurdo continuare a limitare il nostro campo d’azione, perché, anche solo considerando gli italiani che lavorano, vivono o si trovano di passaggio all’estero, si possono fare concerti dappertutto. Ecco, quindi questi sono i primi passi che stiamo facendo verso una “europeizzazione” del nostro pubblico e della nostra storia.
PG: A Parigi vive una grandissima comunità di italiani: che effetto vi fa suonare all’estero davanti a così tanti italiani?
F: Per noi venire a suonare all’estero, davanti agli italiani che hanno fatto la scelta di vita di trasferirsi in un altro paese, è sempre molto bello: si sente un’atmosfera diversa. Nonostante in Francia, in, Germania, in Inghilterra si possa andare a sentire qualunque tipo di musica, il fatto che arrivi il gruppo dall’Italia porta sempre un entusiasmo un po’ diverso rispetto a quello che si riscontra durante i concerti in Italia. Magari è un gruppo che si è ascoltato in concerto dieci anni prima in Italia, e ritrovarselo nella città nella quali si è stati costretti o si è scelto di andare a vivere è sempre molto bello, e questo entusiasmo si trasmette anche a noi. Non snobbiamo certo gli italiani che vengono a sentirci all’estero, anzi, è una bella cosa. Ovviamente, poi, ci fa piacere anche se ci sono degli “indigeni” che ci vengono a vedere, ma suonare davanti agli italiani che sono emigrati all’estero è sempre molto emozionante.
PG: Zulù, nel vostro album Cattivi guagliuni avete scritto una canzone che si chiama Penso che non me ne andrò. Che cosa volevate dire?
Z: Cattivi guagliuni era il primo disco che facevamo dopo quasi dieci anni di scioglimento e quella canzone era una specie di dichiarazione d’intenti, un modo per dire “Siamo tornati per restare”. Insomma non faceva riferimento al rimanere nel proprio paese, anche se effettivamente poteva essere fraintesa. Restare in Italia, oggi come oggi, è un privilegio, un’opportunità, che per alcuni è possibile e per tantissimi no. Ed essendo già sufficientemente doloroso il dover scegliere di lasciare la propria casa, i propri affetti, le proprie abitudini e la propria lingua per andare a confrontarsi con il nuovo, pensiamo che si possa risparmiare ai milioni di italiani che emigrano nel mondo la nostra canzone che li critica dicendo che invece sarebbero dovuti rimanere qui a sostenere il proprio paese. Ecco, non è il nostro pensiero. Ognuno deve sostenere se stesso, se il proprio paese non è in grado di valorizzarti, tu hai il dovere morale di cercare un posto dove la tua dignità sia espressa al massimo possibile.
PG: Come giustamente stanno facendo le centinaia di migliaia di persone che arrivano in Europa.
Z: Certo. Tra l’altro bisogna considerare che oltre ai rifugiati che scappano dalle guerre, ci sono anche altri tipi di profughi che emigrano per via di condizioni di invivibilità causate dal nostro modello di sviluppo: ovvero a causa di squilibri ambientali e geopolitici. Questa politica della globalizzazione, come la chiamano loro, è in realtà soltanto un modo per permettere alle aziende di smantellare, licenziando i lavoratori e aprendo filiali dove la forza lavoro costa meno. Il problema è che, mentre la fabbrica ha la libertà di aprire in Nigeria perché pagare un operaio costa meno, perché l’operaio nigeriano non dovrebbe avere la libertà di venire in Italia dove verrebbe pagato il triplo? Il problema è che la globalizzazione è pensata solo per le aziende e i grandi capitali e non per i corpi delle donne e degli uomini che vivono questo pianeta.
PG: Franco, c’è una vostra canzone di alcuni anni fa, intitolata Di corsa, che era dedicata ai migranti: in questi giorni quella che i media chiamano “la crisi dei migranti” fa la prima pagina dei giornali di tutta Europa. Come vivete questo momento storico?
F: Purtroppo, come tutti, viviamo questo momento storico con una grande sensazione di impotenza. In un certo senso anche noi siamo un po’ profughi: profughi dei sentimenti. L’individualismo non soltanto ha portato ad una disgregazione dal punto di vista sociale, ma ci ha resi più cinici di fronte a certe notizie. Certo, le televisioni ti mostrano questo esodo di migliaia di persone, ma subito dopo inizia la partita di calcio, che ti distrae da un fatto di tale importanza. Un esodo biblico di queste dimensioni è talmente difficile da immaginare, eppure siamo tutti complici, dovremmo sentirci tutti un po’ in colpa.
Noi come gruppo abbiamo sempre cercato di fare quanto possibile nel nostro piccolo, di svuotare il mare col nostro piccolo secchiello: è un’immagine che può sembrare un po’ utopica, ma forse se tutti facessimo la nostra parte – anche da un punto di vista pratico, non soltanto con le parole, o con le canzoni, o con le idee – se tutti facessimo la nostra parte, forse i problemi ci sarebbero lo stesso, ma insieme si potrebbero risolvere molto più facilmente.
Purtroppo viviamo in un’epoca di poteri che vogliono le crisi economiche, che vogliono le guerre: perché non dobbiamo mai dimenticare che c’è sempre chi ci mangia sopra, chi ci si abbuffa sulle guerre! Bisogna cercare di non assuefarsi troppo, bisogna resistere al cinismo. Scardinare quel meccanismo per il quale tutto questo sì, fa un po’ male, ma lo metti in un angolo della tua mente e alla fine lo dimentichi lì, e intanto, fuori non cambia niente.
PG: Il vostro tour si chiama “Resistenza globale”. Resistenza a cosa? Cioè cosa significa oggigiorno resistenza?
Z: Resistenza significa tentare con tutti i mezzi possibili di mantenere la propria identità, collettiva e individuale, in un mondo che tende a togliertela, rivendicare costantemente il proprio diritto ad occupare un posto all’interno della società, e a farlo come meglio si ritiene, senza doversi necessariamente piegare alle logiche della maggioranza. Questo oggi significa resistere: continuare a immaginare un cambiamento in meglio piuttosto che una resa intellettuale allo stato di cose presente. Tra l’altro sono convinto che siamo in una fase storica in cui un cambiamento è già in atto. Sta a noi scegliere se esserne i co-autori oppure se volerlo solo subire. Si tratta di modificare il modello di sviluppo, che poi non significa cambiare una cosa lontana e incomprensibile, ma di essere disposti a rivedere il proprio stile di vita.
F: Credo che questo tema vada interpretato nel senso di rifarsi ai valori della Resistenza della seconda guerra mondiale, ma per applicarli alla società di oggi. Crediamo che si debbano ancora difendere i valori portati avanti nella Resistenza, che si sono un po’ persi in questa società iper-individualista. Per noi il significato centrale della Resistenza oggi è quello di tornare a mettere l’uomo al centro del sistema: l’uomo come persona deve tornare ad essere la priorità, e non il denaro o il potere. Forse oggigiorno la battaglia è ancora più difficile perché il nemico non è delineato e visibile, devi riuscire a raffigurartelo: inoltre l’individualismo ha disintegrato il concetto di unirsi per un comune obiettivo. Per questo i valori che ci vengono dalla Resistenza non sono valori vecchi o stantii, ma, al contrario, sono importantissimi anche al giorno d’oggi.
PG: Franco, tu sei uno dei membri storici dei Modena City Ramblers, con i quali fate musica ormai da più di vent’anni. Come è cambiato il vostro pubblico nel corso di queste lunghissima carriera?
F: Il nostro pubblico è cambiato moltissimo in termine di età, c’è stato un cambio generazionale molto forte e molto evidente, che testimonia che quel che abbiamo fatto non è stato invano. Si è abbassata molto l’età media. Quando abbiamo iniziato, e per molti anni all’inizio, non avevamo un pubblico così giovane. Evidentemente, checché se ne dica, molti tra i giovani degli anni 2000 sono attenti ai temi che affrontiamo nelle nostre canzoni. Adesso quando facciamo i concerti vediamo una grande differenza di pubblico tra il venerdì e il sabato sera: infatti c’è tutto un pubblico che il venerdì non viene ai concerti perché la mattina dopo deve andare a scuola. Ci ha fatto veramente piacere vedere questo cambio generazionale, forse stare in mezzo ai giovani è quello che ci piace di più e che ci dà maggiori stimoli per andare avanti.
PG: Un’ultima domanda per Zulù: nel 2015 chi sono i rafanielli e chi sono le pummarole?
Z: No, nel 2015 non ci sono più i rafanielli. Anche se la facciamo ancora dal vivo, Rafaniello è una canzone che aveva un senso nel contesto in cui era stata scritta. All’epoca, ce l’avevamo contro la dirigenza del partito perché sottraeva tantissima linfa vitale alla nostra area, che in quel momento si stava affermando politicamente. Eravamo e siamo ancora convinti che il cambiamento debba partire da un luogo reale, da un quartiere, da un posto di lavoro, e non certamente da una sede di partito.
Oggi però viviamo in un periodo completamente differente in cui anche solo l’idea di pensare di dare del rafaniello ad un altro perché ha fatto una scelta differente dalla mia mi sembra un po’ fuori luogo. Se fossimo arrivati a un punto cruciale della discussione in cui sembra di essere vicini alla vittoria, soffermarsi sulle differenze sarebbe contemplabile e forse anche necessario. Ma farlo in un momento come questo, in cui è in corso una deriva di qualunquismo e di ignoranza, non avrebbe proprio nessun senso.
PG: Dunque siete ottimisti.
Z: Io non lo so se sono ottimista o pessimista. So che non ho alternative, quello che faccio è l’unica cosa che so fare e che mi sento di fare. Di base la nostra scelta di militare nei movimenti nasce dalla convinzione che i partiti offrano delle soluzioni ai tuoi problemi ma attraverso tutta una serie di mediazioni che rendono il procedimento lento e complicato. L’idea del movimento è invece quella di riappropriarsi ora e subito di quello di cui hai bisogno. Per noi non si tratta di raggiungere un qualsivoglia obiettivo: già il fatto di avere dimostrato ancora una volta di poter essere quello che si è in un mondo che tende sempre a dirti che invece è assolutamente impossibile per me è già una grande vittoria. Se questo significa essere ottimisti, allora sì, sono ottimista, perché ho 45 anni e un figlio, mentre il mondo mi aveva dato per morto quando ne avevo fatti 20. Quindi diciamo che già il fatto di stare facendo questa intervista a casa mia, con mio figlio che sta per tornare da scuola è per me una vittoria.