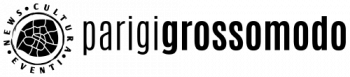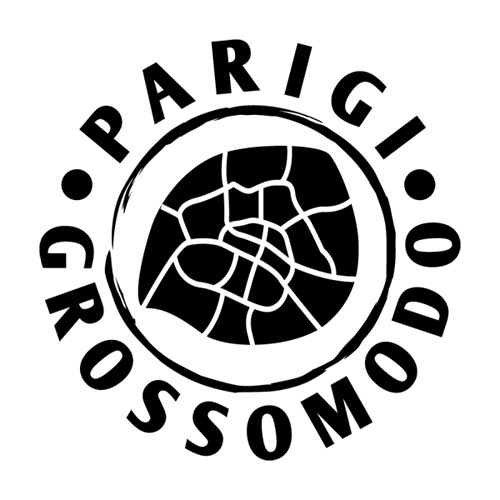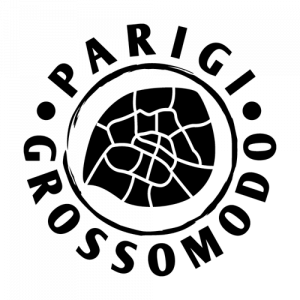Nell’Accordo di Parigi della Convention-cadre sur les changements climatiques redatto a conclusione della COP21, la parola développement ricorre 103 volte, développé 120, croissance soltanto una volta, ma quanto basta: “Il est essentiel d’accélérer, d’encourager et de permettre l’innovation pour une riposte mondiale efficace à long terme face aux changements climatiques et au service de la croissance économique et du développement durable”, recita il comma 5 dell’articolo 10.
Sviluppo, paese sviluppato, paese in via di sviluppo, paese sottosviluppato, crescita. A giudicare dalla frequenza e dall’unanimità con la quale tali espressioni sono impiegate dai media, dalle istituzioni, ma anche dai comuni cittadini nel loro linguaggio quotidiano, si direbbero innocui appellativi che servono a distinguere i paesi del nord da quelli del sud e a definire un grado più o meno soddisfacente di benessere all’interno della società umana, a sua volta suddivisa in nazioni. In realtà sottintendono un dogma: quello per cui tale benessere deriverebbe da un determinato tipo di sistema economico, quello su cui si fondano le nostre società, nato con la Rivoluzione industriale, basato sulla concorrenza e la competizione, la produzione di massa, la pubblicità, il commercio globale, il lavoro salariato e/o la disoccupazione.
Eppure se c’è una cosa che di questa COP21 è stata chiara a tutti è proprio il suo obiettivo: limitare il riscaldamento globale sotto la soglia dei +2°C (nella migliore delle ipotesi del +1,5°C) rispetto alla temperatura terrestre nell’era postindustriale. Insomma, perché non è bastato questo a suggerire all’élite mondiale che forse il problema vero sono proprio l’industria e l’adesione globale all’attuale sistema economico? Non prendere nemmeno in considerazione l’idea di poterlo mettere in discussione è, dal mio punto di vista, un errore di fondo e, oserei dire, una colpa dall’estrema gravità, dal momento che è in gioco la vivibilità stessa del nostro pianeta.
E’ una questione di logica.
I miei nonni vivevano in montagna. Avevano delle mucche che portavano al pascolo. Ci ricavavano il latte con il quale facevano il formaggio. Nell’orto coltivavano i fagioli, le verdure e il granturco che portavano al mulino per farlo macinare. Non c’erano resti perché tutto quello che avanzava finiva in pasto alle galline, che facevano le uova. Ci si muoveva a piedi o in bicicletta. Quasi nessuno aveva la macchina, ma qualcuno in paese suonava la fisarmonica e si andava a ballare. Emissioni di gas a effetto serra: prossime allo zero.
Io vivo in una metropoli, non coltivo né allevo quello che mangio. Potrei aver vissuto finora senza aver mai visto un orto, una gallina o un maiale, perché tanto al supermercato posso comprare le uova, le verdure, la carne e il formaggio coltivati e allevati a qualche chilometro oppure dall’altra parte del mondo, arrivati con i trasporti alimentati grazie alle energie fossili. Posso mangiare i pomodori, le zucchine e le melanzane in tutti i mesi dell’anno, grazie ai pesticidi e alle serre riscaldate. Posso comprare del cibo perché ho un lavoro che mi fornisce del denaro. Per andarci prendo la metropolitana. Per eseguirlo, mi servo di un computer che resta acceso 24 ore su 24. Qui intorno non ci sono prati né pascoli e la città è molto stressante, così ogni tanto ho voglia di farmi un viaggio. Visto che devo lavorare, perché se non lavoro non ho i soldi per mangiare, mi resta poco tempo per fare un viaggio, allora mi tocca fare in fretta e prendo l’aereo perché è un mezzo di trasporto velocissimo. Emissioni di gas a effetto serra: nettamente al di là della logica. E pensare che non ho neanche la macchina.
Insomma, a mio avviso, sono proprio il concetto di sviluppo e di crescita economica, con quella loro aria così neutrale, con il loro presentarsi come un dato di fatto inconfutabile, a nascondere subdolamente il vero nocciolo del problema, il germe dell’illogicità globale. Il loro presupposto è che una società, per essere in salute, debba produrre e vendere sempre di più. Basta. E da qui, tra le altre, l’aberrazione di oggetti programmati per rompersi in fretta, non sia mai che la durevolezza freni la produzione e la vendita illimitata. Insomma, quando leggo documenti ufficiali che parlano di “une riposte mondiale (…) face aux changments climatiques et au service de la croissance économique et du développement durable”, mi si gela il sangue nelle vene. Davvero stiamo ancora parlando di produzione illimitata? Non si è ancora capito che la soluzione è smettere di produrre? Che la maggior parte delle cose che produciamo sono inutili e inquinanti? Che la pubblicità, indispensabile a farci sentire il desiderio di acquistarle, è inutile e inquinante a sua volta? Che la maggior parte dei lavori che facciamo non ha senso perché fa parte di un ingranaggio troppo grande del quale abbiamo perso il filo?
Affrancarsi dal dogma, ritrovare la logica delle cose sono azioni indispensabili per uscire da un circolo vizioso che ci sta portando verso la catastrofe.
(Questo articolo è disponibile anche in francese: COP21, l’accord ne saisit pas le problème)