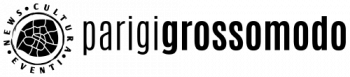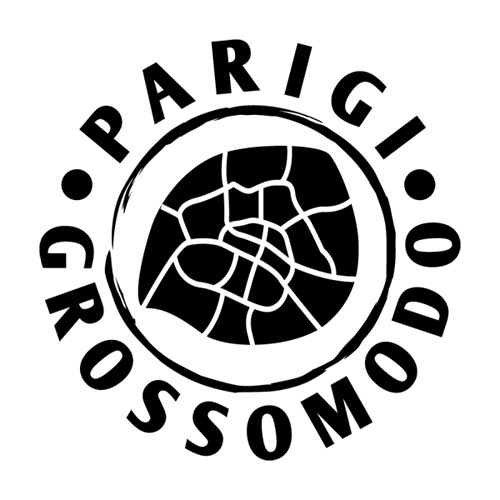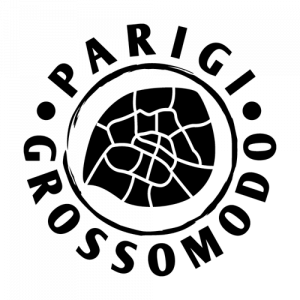“Parigi è una città fredda e ostile” si lamentano spesso gli immigrati quando si ritrovano tra di loro. Quando, però, quando quella stessa città comincia a lasciarci delle fessure dalle quali penetrare nei suoi meccanismi l’immagine che ne abbiamo inizia a cambiare. E cominciamo a cambiare anche noi, a diventare sempre più simili ai nostri concittadini, a copiare i loro tic, a farsi contagiare dall’ultima idiosincrasia linguistica alla moda, frequentare i loro luoghi di ritrovo. Inizialmente presi nel vortice della novità non percepiamo neppure il cambiamento, finché, un giorno, la verità non ci salta agli occhi: Parigi è un teatro, dove tutti recitiamo continuamente la nostra parte. Parigi è un teatro dove tutti recitano in continuazione, secondo codici non scritti ma tangibilissimi.
Non scritti fino ad un certo punto, del resto: Parigi ama parlare di se stessa. Ogni anno escono decine di libri su Parigi, ma le case

editrici non si stancano mai di pubblicarli: Parigi della parigina, Parigi del parigino, Parigi nascosta, Parigi branché, Parigi per i bambini… Libri che ripropongono, inevitabilmente gli stessi cliché, conditi da liste interminabili di place to be, indirizzi incontournables e altri consigli. E quante volte avrete letto quei test che iniziano sempre con “Tu sais que t’es parisien si…”, seguiti da una serie di situazioni più o meno simpatiche nelle quali il “parigino” si comporta da parigino… Insomma, il concetto è chiaro: stando agli stessi, essere parigini è uno stato mentale, non una mera indicazione geografica.
Uscite la sera con i colleghi? Ovviamente non andrete a prendere una birra nel bar di fronte al lavoro: vi trascinerete fino al quartiere di tendenza del momento e, in mezzo a una via che conta più bar che piccioni, cercherete di infilarvi in quello più pieno perché è il più sympa. Che cosa cambia tra il vostro bar sympa e gli altri? Assolutamente niente, sennonché il vostro è recentemente apparso su Elle, Le Fooding e My little Paris. Ma… Attenzione! Adesso il gioco si fa duro: assolutamente vietato, anche se siete alle prime armi, dire che l’avete letto su My little Paris o Time Out, a meno di non volervi incollare in fronte l’etichetta del provinciale. Potete citare Le fooding, così come Elle (ma solo se avete più di 30 anni e un look assolutamente personale) e Vanity Fair (solo per qualche mese ancora, finché sarà una novità). Non chiedetevi perché, non c’è una ragione.
Ovviamente tutti questi consigli potrebbero non essere più validi tra sei mesi, perché come le oche selvatiche migrano per l’inverno senza chiedersi perché, così a Parigi da una settimana all’altra un personaggio, un luogo, una rivista passa dall’essere in all’essere démodé (anzi, avrei dovuto dire vieillot, perché démodé è una parola démodé).
Come fare allora a far presente all’allegra combriccola che quel bar lo conoscete anche voi? La miglior frase è “me ne hanno parlato”. Chi ve ne ha parlato? Che domande, “un pote”, che immancabilmente fa il dj o scrive recensioni di ristoranti. Il che, di per sé non è neppure così improbabile: stando alle conversazioni iniziate nei locali, a Parigi si può incontrare un numero decisamente ristretto di categorie socioculturali. Insomma, nessuno che conosca mai un fattorino di runner pizza o un idraulico, tutti fanno lavori interessantissimi (anche se, all’ennesima tipa che ti dice “moi je fais la com”, ti cominci a chiedere se ci sia poi tutto ‘sto bisogno di comunicatori).
Ovviamente questa smania per i locali dove “vedere ed essere visti” è solo un aspetto, e dei meno fastidiosi di questa enorme vetrina che è la Ville Lumière forse retaggio della Belle Epoque, quando nei caffè si sedeva per veder passare il bel mondo. Seguono i vernissage delle mostre, da frequentare anche quando non si capisce niente di arte non tanto per legittima curiosità ma giusto per darsi un tono; l’arte di farsi dei contatti elevata a qualità suprema per sopravvivere nel mondo del lavoro; il continuo ricorso a etichette che possano classificare tutto (luoghi, persone, abiti, accenti, espressioni culturali) quali geek, bobo, hipster, wesh wesh, che trasformano le persone in figurine panini (“c’ho un amico hipster, mi manca l’amico geek”); per non parlare del concetto aberrante di Culture gé (Culture génerale per esteso). La culture gé contiene tutto e significa tutto, ovviamente in formato pillole, perché è quella che serve per “briller en soirée”: va da sé che per fare bella figura in società non c’è differenza tre conoscere l’anno della scoperta dell’America e il nome del primo disco di Eve Angeli.
Come sopravvivere a questa vita in vetrina? Credo serva un mix di camouflage, senso del limite (anche se siete nel bar più in del momento ricordatevi che il cheeseburger che pagate 25 € è una svizzera in un panino), qualche scappatella lontano da Parigi (per riscoprire il senso di chiacchierare per il puro piacere della chiacchiera), molta ironia e un po’ di autoindulgenza. Perché alla fine su questo palco ci recitiamo tutti, e alla nostra parte, magari, ci siamo anche un po’ affezionati.