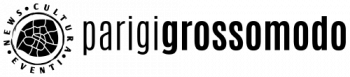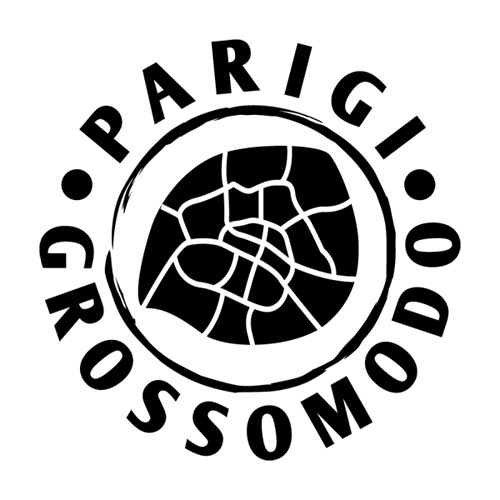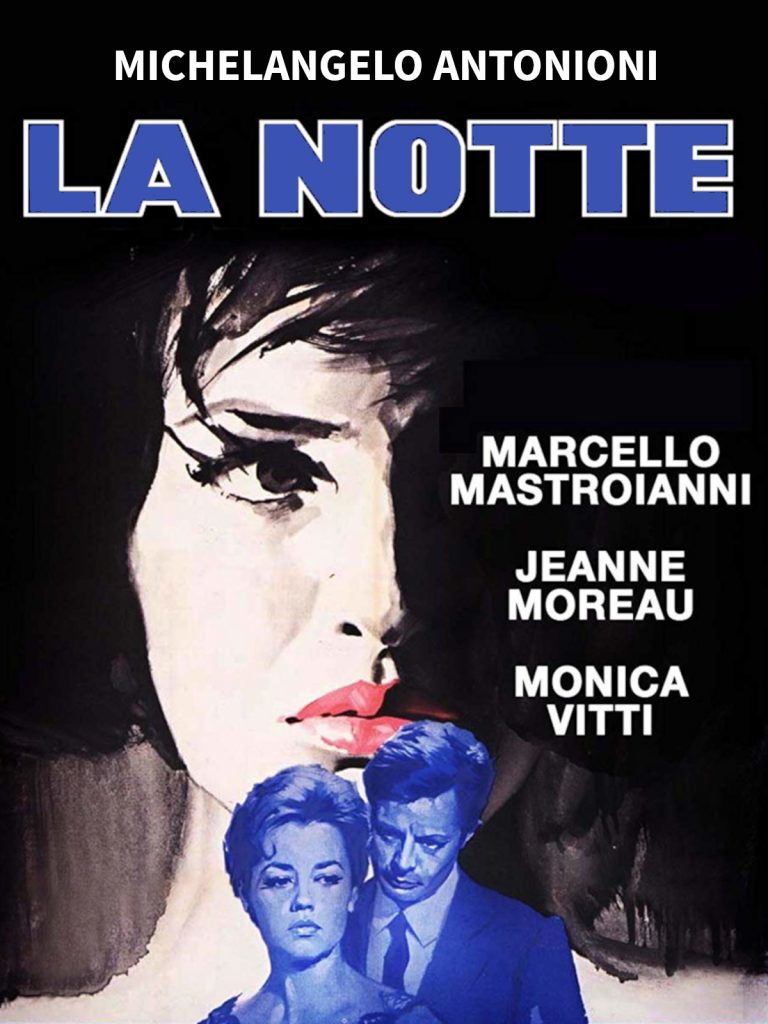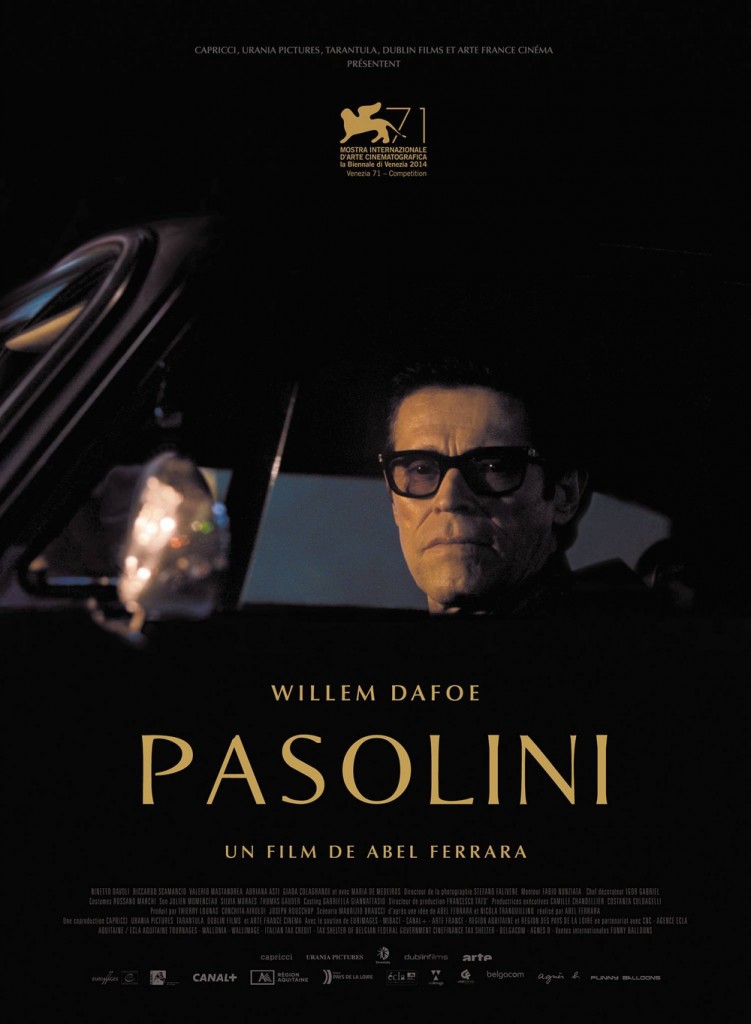Il film del mese: “Pompei, sotto le nuvole” di Gianfranco Rosi
Lo avevamo annunciato all’inizio di novembre: Pompei, sotto le nuvole, il nuovo documentario di Gianfranco Rosi, vincitore del Premio Speciale della Giuria alla Mostra del Cinema di Venezia 2025, arriva finalmente nelle sale francesi. Dopo aver raccontato, tra gli altri, il raccordo anulare A90 attorno a Roma in Sacro GRA (2013, Leone d’Oro a Venezia) o l’isola di Lampedusa, porta d’ingresso in Europa per molti migranti in Fuocoammare (2016, Orso d’Oro a Berlino), questa volta il regista ha scelto Napoli, dove ha filmato per tre anni sotto l’impassibile presenza del Vesuvio. Da un certo punto di vista, è proprio il vulcano il vero protagonista del film, come suggerisce già l’apertura con una citazione di Jean Cocteau: “Il Vesuvio fabbrica tutte le nuvole del mondo”.

Girato in uno splendido bianco e nero, il film racconta la vita dei napoletani di oggi e il modo in cui continua a essere segnata dal passato, dalla storia e dal timore costante dell’imprevedibilità del vulcano. Con un montaggio alternato estremamente curato, Rosi segue persone il cui quotidiano è intimamente legato alla città: chi in modo permanente: la conservatrice del Museo Archeologico, custode delle collezioni di sculture antiche non esposte; i pompieri che rispondono alle chiamate di emergenza; un procuratore che indaga sui saccheggi di tombe; e chi in modo temporaneo, come un marinaio siriano venuto a scaricare un carico di grano ucraino al porto o un gruppo di archeologi giapponesi impegnati in uno scavo. Dopo averli filmati per mesi, Rosi restituisce spaccati di vita poetici e di grande sincerità. E riesce anche a mettere in relazione queste esistenze, talvolta molto diverse, abbozzando una risposta alla domanda: “Che cosa significa vivere oggi sotto le nuvole del Vesuvio?”
Il film rovescia subito ogni cliché mostrando immagini di vecchie pellicole proiettate nello schermo di un cinema abbandonato (Viaggio in Italia di Rossellini, Gli ultimi giorni di Pompei del 1913…). Poi costruisce un dialogo continuo tra le tracce di un passato immobile (statue, sculture, corpi pietrificati) e un presente in movimento perpetuo: le persone, il mare, i treni, il fumo del vulcano. Tutta la vita contemporanea sembra orbitare attorno al passato, proprio come i turisti che girano attorno alle vetrine dei siti archeologici. Ed è, in fondo, la realtà stessa del nostro mondo: le navi cargo che oggi trasportano grano dall’Ucraina all’Italia non ripercorrono forse lo stesso tragitto delle imbarcazioni dell’Impero Romano citate dall’archeologo giapponese? E gli abitanti che chiamano i pompieri per chiedere se le scosse sismiche avvertite siano pericolose non condividono forse la stessa paura atavica dell’eruzione che distrusse Pompei ed Ercolano duemila anni fa?
Il film insiste anche sul ruolo della cultura come vettore di memoria e di coesione: attraverso l’attaccamento dei personaggi alle opere antiche, alla loro scoperta e conservazione, alla consapevolezza della perdita rappresentata dagli affreschi sottratti dai tombaroli; oppure attraverso figure come Titti, l’anziano educatore di strada che recita poesie ai bambini che aiuta nei compiti o legge I miserabili in dieci giorni sotto i loro occhi ammirati.
A tratti toccante e a tratti divertente, con una bellezza visiva che trova pieno respiro solo sul grande schermo, Pompei, sotto le nuvole arriva nelle sale francesi da mercoledì 19 novembre. All’occasione dell’uscita in sala, abbiamo incontrato Gianfranco Rosi: ecco cosa ci ha raccontato.
La nostra intervista a Gianfranco Rosi
Parigi Grossomodo: Per iniziare, può dirci com’è nata l’idea di questo film… O meglio, se c’è stato un momento in cui la voglia di fare questo film si è trasformata in un vero progetto?
Gianfranco Rosi: La voglia di fare un film a Napoli, in realtà, è sempre stata lontanissima da me. Napoli è una città complessa, ed è una città che è già stata tantissimo filmata. Non è mai stato un territorio in cui pensavo di potermi immergere a lungo per un progetto. Poi il mio amico Pietro Marcello mi ha suggerito alcuni luoghi e situazioni da osservare, e questo sguardo “da dentro” mi ha fatto percepire una Napoli diversa, più nascosta. Il fatto che un napoletano mi avesse aperto una porta è stato lo stimolo che mi ha fatto pensare a questa sfida. Quando sono tornato a Napoli per la proiezione di Fuocoammare, ho iniziato a esplorarla da solo e ho capito che quella sfida potevo accettarla. Per me un film nasce sempre nel tempo: so quando inizio, ma non so quando finirò, perché sono gli incontri con le persone, le situazioni, il paesaggio a determinare il racconto. E tutto si costruisce lentamente, attraverso un rapporto di fiducia.
PG: Lei ha girato tre anni a Napoli…
GR: Quattro anni, con un anno di interruzione, quando ho fatto il film sul Papa, In viaggio. Però di fatto ho girato per tre anni. Napoli è diventata parte della mia quotidianità.
PG: Quindi quest’idea di film c’era già da prima?
GR: No, è stata un’idea molto immediata. Ho scritto poche pagine iniziali. Quello che mi ha colpito, nel cercare una forma di racconto per Napoli, è stata una riflessione sul tempo sospeso.
Più che uno spazio, ho voluto raccontare il tempo: il tempo della Storia che si riflette costantemente su Napoli e su questo territorio; questa zona di passaggio tra il presente, ciò che è stato e ciò che potrebbe essere. Una stratificazione di tempo sospeso. Napoli vive costantemente millenni di storia: c’è sempre una sorta di “fuoricampo” permanente. Non c’è niente che tu guardi che non nasconda duemila anni di storia.

PG: Ha cominciato subito a filmare?
GR: Sì. Negli altri film ho sempre passato molto tempo senza cinepresa, senza filmare, solo per osservare. In questo film invece ho sentito la necessità di iniziare a girare immediatamente.
Ogni film ha un metodo diverso di lavoro. Qui, oltre a girare, per me è stato importante fare da subito un montaggio parallelo: ogni volta che c’erano delle storie o delle situazioni che crescevano e diventavano potenziali soggetti, sentivo la necessità di riscrivere il montaggio fin dall’inizio, in parallelo alle riprese. Riprese e montaggio sono quindi andati avanti insieme per tre anni, con Fabrizio Federico, che è il montatore del film.
PG: Come ha trovato e scelto i personaggi del film?
GR: Io non faccio mai un casting in senso classico. Sono tutti incontri casuali. È come quando Calvino dice: “La verità è qualcosa che ti viene incontro e ti costringe a girarti, e nel momento in cui ti giri non esiste più”. Quell’atto di girarsi e di guardare: questi sono i miei incontri. Gli incontri sono il tempo del film: il tempo per creare rapporti, per cercare di raccontare anche attraverso la sottrazione, non solo fornendo informazioni continue, ma costruendo comunque un racconto, una drammaturgia. Questo richiede tempo. Il mio investimento più grande è il tempo: lavorare da solo mi permette di entrare davvero in una situazione di intimità, di attendere anni, di capire quando bisogna lasciare un luogo e quando bisogna tornarci, quando spostarsi su un’altra storia, un altro incontro.
Sono tutte situazioni che piano piano si allargano e diventano parte di un racconto organico.
PG: Con i diversi personaggi, lei ha girato per “blocchi”, uno per volta?
GR: No, sono sempre stati alternati. C’erano periodi in cui stavo di più con una storia o una situazione, poi la lasciavo, poi ci tornavo. Tutto questo si è costruito nell’arco di tre anni: nel tempo le storie sono cresciute, gli incontri si sono moltiplicati, ma sono sempre stati alternati.
Quasi mai ho “consumato” una storia in un unico momento. L’unica eccezione è stata con la nave dei siriani: lì ho avuto solo cinque giorni per immergermi in quella storia, e quasi tutto il film, per quella parte, è nato da quei cinque giorni.
PG: Come ha incontrato Aboud, il marinaio siriano, e come si è presentata la sua storia?
GR: Questa storia è legata al grano. Avevo iniziato a girare prima ancora di imbarcarmi sulle navi: i silos, il grano mi affascinavano. Avevo già girato la storia con l’archeologo giapponese che parlava del grano, nello stesso porto… Quasi tutte le storie si svolgono in questa zona: Pompei è a pochi minuti di macchina, Ercolano è lì vicino, tutto si tiene in questo territorio. Ho iniziato a girare, ma era molto difficile ottenere i permessi per salire sulle navi. Prima di quella nave ho già girato su tre o quattro navi siriane, ma non avevo mai incontrato “il” personaggio: non c’era ancora stata quella situazione che ti obbliga a restare, a capire dove mettere la macchina da presa. Cercavo di filmare la storia del grano, questi lavoratori quasi schiavi moderni, totalmente sfruttati in questa situazione dolorosa, ma ancora non c’era stato un vero incontro.

Invece, quando è arrivata la nave di Aboud, dopo cinque minuti ho capito che lui poteva essere uno dei protagonisti del film, perché da parte sua c’era la necessità di raccontarsi, di condividere il proprio dramma. Anche queste navi che attraversano la guerra… ecco, è un altro fuoricampo importantissimo. Portano al porto di Napoli il dolore della guerra, il rischio della morte che queste persone affrontano per trasportare farina, grano a Napoli.
PG: Nel film c’è quel momento in cui l’archeologo giapponese spiega ai ragazzi il circuito del grano nell’antichità, come un’eco del passato alla storia dei marinai siriani che oggi portano il grano dall’Ucraina… In generale nel film, c’è anche l’idea di mostrare che tra passato e presente è cambiato poco?
GR: Non sé è “cambiato poco”, però ci sono dei passaggi che sembrano essere lì da duemila anni, come Titti. Tutti i personaggi che ho incontrato hanno in comune una sorta di devozione laica: Maria, il procuratore, Titti, i siriani, il fotografo Giorgio, i tombaroli… c’è sempre questo dialogo tra presente e passato, e al tempo stesso c’è in tutti loro un concedersi a qualcosa o a qualcuno, fare qualcosa per gli altri.

Come dice Pasolini, una civiltà nasce quando qualcuno comincia a fare qualcosa per gli altri. Questo porta anche un elemento di speranza nel film: in un film dove il senso della paura emerge costantemente – la paura dettata dalla natura, dai terremoti – c’è anche una paura universale, che appartiene al nostro tempo. Viviamo in un mondo dove la paura è un elemento costante, pensiamo alla guerra. C’è un personaggio che “fa la guerra ai terremoti, non sappiamo più come andare avanti”. La paura è un sentimento che si esprime nello stesso modo anche se ha origini diverse.
In questo senso il film è fatto di sentimenti universali: paura, sospensione, l’idea di un futuro possibile. Napoli diventa un laboratorio universale dove sperimentare una sorta di “futuro anteriore”: succede qualcosa adesso, ma è proiettato verso il futuro, verso tanti futuri possibili.
PG: Il film mostra Napoli come una terra di contrasti: la dolcezza del personaggio di Titti, i pompieri molto simpatici, anche di fronte alle domande a volte un po’ strane che ricevono…
GR: Il Centro di Coordinamento dei pompieri diventa una specie di luogo in cui tutta Napoli si immerge: tra domande legittime e paura. I pompieri sono una sorta di tramite, una figura che rassicura. Anche lì c’è un enorme senso di devozione: confortare, tranquillizzare… Quando ho scoperto questa stanza ho capito che poteva essere il fil rouge del film: dove tutta Napoli si riversa in quella stanza, e lì tutto si trasforma in un dramma umano, come un radiodramma, dove tu immagini attraverso queste voci le situazioni, e in questo modo questa sala operativa diventa l’eco di un mondo esterno.
PG: E c’è anche la violenza, al contrario: i pompieri che quando escono hanno bisogno della polizia per proteggersi… In tutti questi contrasti, tra dolcezza e violenza, o tra passato e presente, mi chiedevo se la scelta del bianco e nero fosse anche un modo per esprimere questa dimensione.
GR: Il bianco e nero per me è stato un modo per trasformare la realtà, ma anche un’esigenza narrativa: volevo che il presente entrasse subito a far parte dell’archivio, che fosse già percepito come un passato. Questa drammaturgia dell’archivio trova la sua forma più chiara nel cinema distrutto: lì l’immagine d’archivio sopravvive solo attraverso lo schermo, anche quando lo schermo non esiste più. Diventa metafora, diventa cinema, un racconto parallelo.
PG: Qual è il ruolo della musica? Avete lavorato insieme a Daniel Blumberg per scegliere i momenti in cui inserirla?
GR: All’inizio pensavamo di usare la musica solo nella scena finale, poi abbiamo capito che poteva creare un ponte tra l’inizio e la fine. Alla fine ci sono undici interventi sonori, quasi impercettibili, che danno al film un altro respiro. Con Daniel abbiamo lavorato in modo molto preciso: non volevo che si riconoscessero gli strumenti, e lui ha quindi registrato dei sax suonati sott’acqua, creando suoni che modificano lo spazio, dei suoni ancestrali che sembrano venire dalla terra. All’inizio non ti accorgi nemmeno che c’è una colonna sonora, ma quella musica introduce una sospensione del tempo e dello spazio.
PG: Si parla spesso difil rouge quando si parla della filmografia di un regista. Lei sente una continuità tra le sue opere?
GR: Io non penso mai ai miei film in termini di continuità. Ogni film, per me, è come il primo e l’ultimo. Cerco sempre di dimenticare i film precedenti. La continuità, se c’è, è nel metodo: non impormi mai sulla realtà, ma lasciare che sia la realtà a imporsi a me. Questo non cambia mai. Però ogni film ha esigenze diverse di racconto: ogni volta bisogna dimenticare l’esempio precedente e lasciare che emerga una nuova realtà, trovando di volta in volta una forma diversa per raccontarla.
PG: Visto che gira i suoi film su periodi molto lunghi, ha l’abitudine di lavorare in parallelo su altri progetti, o si dedica solo a uno?
GR: No, è già troppo così. Ho bisogno di un’immersione totale all’interno del racconto. Per me è necessario vivere completamente quella realtà che all’inizio non conosco. Come dicevo prima, c’è il tempo del film e il tempo dell’incontro con i personaggi e le storie.
PG: Adesso sta già sviluppando un altro progetto?
GR: No, per adesso sono in pausa. Sto seguendo il film, e poi vedremo. Potrebbe essere anche l’ultimo.
PG: Ci auguriamo di no!