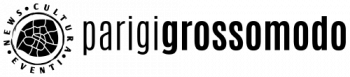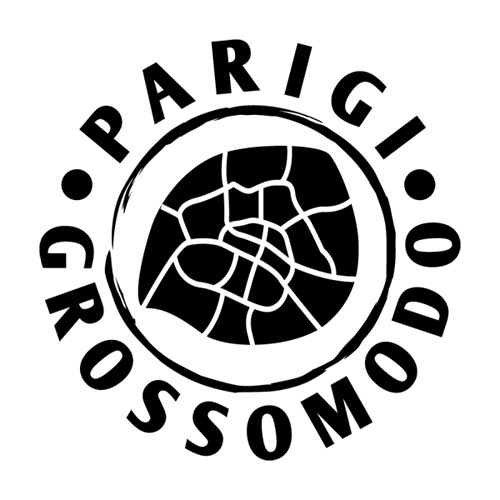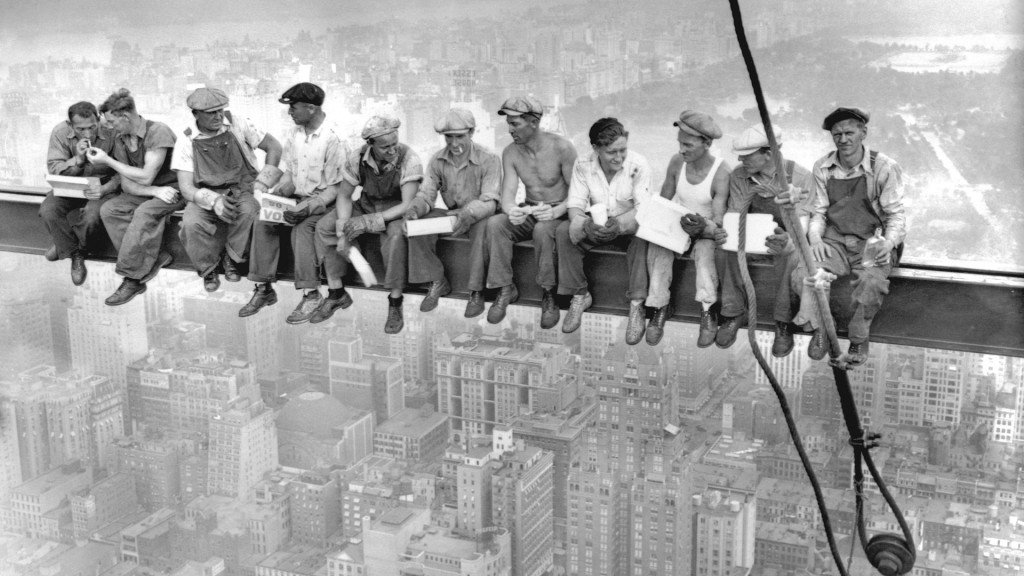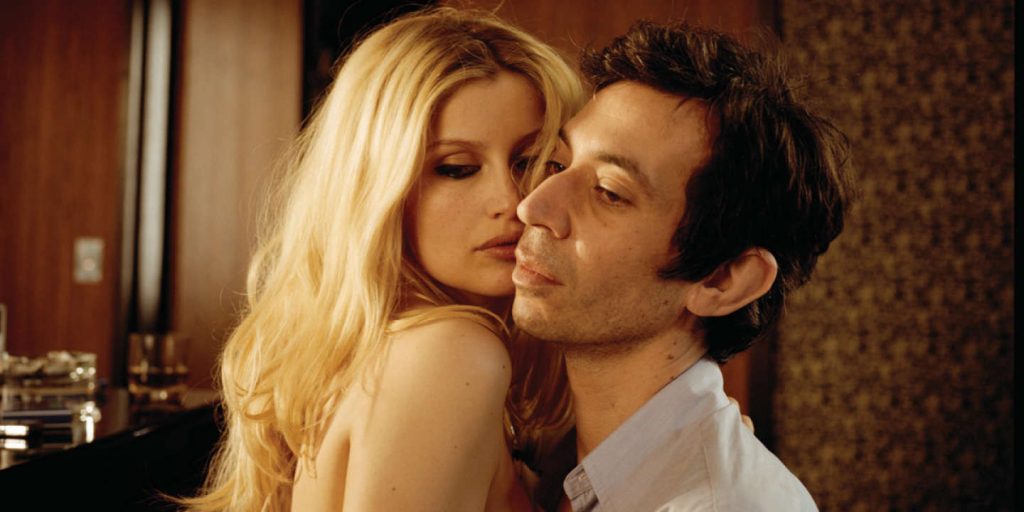Ici l’article en français
Certi addii – e certi arrivederci – avvengono all’improvviso. Ci capitano così, tra capo e collo, senza che abbiamo avuto tempo di rifletterci, di sentirli avvicinare, e ci lasciano – a volte – un po’ tramortiti a fare i conti con un’assenza che non avevamo previsto.
Altre volte invece, le separazioni prendono il tempo di un lungo congedo, in cui crogiolarsi, in cui specchiarsi un’ultima volta prima del fatidico addio – o arrivederci. È il caso del Centre Pompidou, la cui chiusura, prevista per il 22 settembre, non soltanto era annunciata da più di due anni, ma è avvenuta in modo progressivo, come quando si chiude la casa di qualcuno che abbiamo tanto amato e che non c’è più. Quasi con tenerezza.
La prima a chiudere, all’inizio di marzo, è stata la Bpi, mitica Biblioteca di Informazione Pubblica in cui chiunque abbia studiato a Parigi, non fosse che per un anno, ha senza dubbio passato qualche ora seduto a uno dei suoi immensi tavoli. Sicuramente non la più pratica delle biblioteche parigine, vantava però l’invidiabile orario d’apertura serale, che permetteva ai lavoratori di approfittare di qualche ora di studio dopo l’ufficio e agli studenti in ritardo per gli esami di tirare tardi, prima di concedersi una meritata birra all’Art Brut, in rue Quincampoix.
È stato poi il turno delle collezioni permanenti del Musée National d’Art Moderne, che dopo aver chiuso al pubblico in primavera stanno ancora dando del filo da torcere alle équipes del museo, che si trovano a fare i conti con un trasloco (è il caso di dirlo) monumentale: lo spostamento di 150.000 opere d’arte moderna e contemporanea da Beaubourg ai siti che, negli anni a venire, accoglieranno la seconda più grande collezione al mondo (dopo quella del MoMA di New York).
Resta ormai aperto unicamente il secondo piano (quello in cui – per l’appunto – si trovava la Bpi), che dal 13 giugno al 22 settembre accoglie l’ultima mostra del Centre Pompidou così come l’abbiamo conosciuto: per l’occasione il museo ha lasciato carta bianca al tedesco Wolfgang Tillmans, che ha risposto con un’expo dal titolo poetico e un po’ criptico, ma che risuona come un’eco al nostro commiato: Rien ne nous y préparait, tout nous y préparait.
L’ultimo atto di quest’opera colossale che è la chiusura al pubblico per (almeno) cinque anni del Centre Pompidou è dunque iniziato. Mentre gli ultimi visitatori prenderanno le famose scale mobili per visitare la mostra di Tillmans, ai piani superiori decine di dipendenti del centro (conservatori, curatori tecnici, registrar, fotografi…) lavoreranno instancabilmente per preparare il gran finale: il fatidico trasloco di settembre, che durerà diversi giorni e per il quale saranno impiegati 1.500 semirimorchi. Non sono un’esperta, ma – se volete la mia opinione – sarà meglio non passare in auto dal quartiere in quei giorni…
Cinque anni di lavori per una metamorfosi totale
Una volta calato il sipario, arriverà il momento dei lavori: come già detto, sono previsti cinque anni di lavori prima della riapertura al pubblico di un centro completamente rinnovato. L’urgenza dei lavori era dovuta alla necessità di rimuovere l’amianto presente nella struttura e di ottimizzarne il consumo energetico, ma il cantiere previsto andrà molto al di là di una semplice ristrutturazione e messa in sicurezza dell’edificio. Una volta terminati i lavori, infatti, il nuovo Centre Pompidou avrà fatto pelle nuova e promette degli spazi più accessibili per tutti (persone a mobilità ridotta incluse), più polivalenti e con una maggiore fluidità nei percorsi di visita.

E nel frattempo? Se in pieno cuore di Parigi quello che vedremo per i prossimi cinque anni non sarà altro che un enorme cantiere, non per questo dovremo privarci completamente di ammirare tutte le opere della collezione permanente e, a saper cercare, non mancheranno neppure le mostre di Beaubourg… ma fuori da Beaubourg!
Per quanto riguarda la collezione permanente, infatti, una parte delle opere verrà accolta a partire dall’autunno 2026 nel nuovo Centre Pompidou Francilien – Fabrique de l’art, attualmente in costruzione a Massy. Iniziato nel 2018, ben prima che si rendesse necessaria la decisione di chiudere Beaubourg, la direzione del Centre Pompidou si trova così tra le mani un altro cantiere monumentale: 30.000 mq per questo “polo d’eccellenza per la conservazione e la restaurazione delle opere”, che sarà ugualmente aperto al pubblico con mostre temporanee ed esposizioni permanenti.
Per quanto riguarda le mostre temporanee, invece, potremmo parlare di un “museo diffuso”… o di una costellazione! Quest’anno, infatti, sono numerose le expo che potremo visitare un po’ dappertutto in Francia. A Lille, per esempio, dove al Tripostal si tiene la mostra Pom Pom Pidou, oppure al Centre Pompidou di Metz, che fino a febbraio 2026 accoglie Dimanche sans fin, Maurizio Cattelan, con numerose opere in prestito da Beaubourg. E se la Bpi riaprirà alla rentrée nel XII arrondissement, sarà il cinema Mk2 Bibliothèque a raccogliere il testimone della programmazione cinematografica di Beaubourg.
A Parigi, invece, sarà il Grand Palais ad accogliere per i prossimi anni le mostre firmate Centre Pompidou. E si inizia fin da subito con l’esposizione Niki de Saint Phalle, Jean Tinguely, Pontus Hulten, che sarà aperta al pubblico fino al 4 gennaio 2026. Si inizia proprio in grande… e non è un caso!
In effetti, la coppia Saint Phalle-Tinguely fa parte dei nomi che hanno fatto la storia del Centre Pompidou, sostenuti incondizionatamente da Pontus Hulten, primo direttore del Musée National d’Art Moderne e amico dei due artisti, ai quali negli anni il museo, sotto la sua direzione, ha dedicato due retrospettive monografiche (1980 per Saint Phalle e 1988 per Tinguely).
Un progetto unico nel suo genere
Fu proprio il duo Saint Phalle-Tinguely a firmare la prima mostra organizzata all’apertura di Beaubourg, nel 1977. Sempre che di mostra si possa parlare: Le Crocrodome de Zig et Puce (questo il nome dell’opera) era un’installazione monumentale, un mostro a forma di dragone nato dalla fantasia di Tinguely e realizzato da un gruppo di artisti (tra i quali Luginbühl e Spoerri) riuniti sotto lo pseudonimo di Zig et Puce. Installazione interattiva, si direbbe oggi, pensata come una giostra gigante di cui si invitano “gli adulti a fare un uso culturale”, mentre “i bambini ne faranno un uso ludico”, senza che sia escluso, ovviamente, “per gli individui delle due categorie di invertire i ruoli”, come invitava già all’epoca il museo.
A metà tra l’ammasso di ferraglia e il circo itinerante, il Crocrodome rappresentava già all’epoca lo spirito del Centre appena inaugurato da Valéry Giscard d’Estaing (Pompidou, che ha lasciato il suo nome al museo, morì prima della fine dei lavori): “l’ingresso della strada nel museo”, fu detto. Un museo che aveva come prima ambizione proprio quella di avvicinare all’arte e alla cultura qualunque pubblico, di essere a sua volta aperto alla strada. Alla vita.

Fu con questa idea che un binomio di architetti, all’epoca poco più che trentenni (Renzo Piano e Richard Rogers), immaginarono, disegnarono e realizzarono quell’edificio che all’epoca suscitò non poche polemiche, ma che con gli anni tutti (o quasi tutti) i parigini han finito per amare. Con questa idea che non si scelse di fare un ingresso monumentale, ma semplicemente una serie di porte, piuttosto anonime, che davano accesso al forum al piano terra. E sempre per questa idea che davanti all’edificio si apre la Piazza – in italiano nel testo, per così dire: perché è il nome ufficiale dello spiazzo in discesa sul quale generazioni di visitatori si sono seduti per terra, con o senza panino/birra/gelato, per riposare, discutere o semplicemente ammirare il viavai dell’edificio, con le sue innumerevoli entrate e la stravagante scala mobile tubolare della facciata.
Ma, insomma, che cos’era (ed è) di preciso il Centre Pompidou?
Perché, fin dalla sua apertura, nel 1977, il Centre Pompidou (o meglio, Beaubourg, come lo hanno ribattezzato i parigini) è sempre stato qualcosa di diverso da un museo, ma anche da un cinema o da una biblioteca: tutte funzioni che gli appartengono comunque, ma che non sono mai bastate a definirlo. Perché la sua essenza, alla fine, è sempre stata altrove, nell’ideale che ha incarnato per decenni.
Quello di essere un luogo di creazione e di sperimentazione artistica, in primis. Innumerevoli le esposizioni che ne hanno marcato la storia, che hanno interrogato il pubblico, che lo hanno scioccato a volte. Che – ogni tanto – hanno rimesso in causa lo *status quo*. Come quando nel 2009, ben prima che il movimento #MeToo desse nuova linfa (tra l’altro) alle lotte per lo spazio delle donne nell’arte e nei musei, organizzò elles@CentrePompidou, presentando più di 350 opere di artiste donne. Un’istituzione viva, umana e profondamente ancorata nel suo tempo.
Ma neppure questo, in realtà, basta a definire cosa è stato per noi che Parigi la viviamo al quotidiano, il Centre Pompidou. Perché per noi Beaubourg era il luogo di tanti appuntamenti, di incontri casuali, di flânerie artistiche (o meno). Era un luogo in cui si poteva anche solo capitare… ed essere. Soprattutto per coloro che sono abbastanza vecchi per averlo vissuto prima del Plan Vigipirate, che dagli attentati del 2015 ha cambiato irrimediabilmente il modo in cui viviamo i luoghi o investiamo lo spazio pubblico.
Bastava darsi appuntamento là, nel forum, e poi lasciare che le cose accadessero: una mostra, un giretto alla collezione permanente, una proiezione… oppure un caffè, in attesa di un concerto all’Ircam, annesso del Centre Pompidou meno conosciuto ai non parigini, e dedicato alla ricerca in ambito musicale. Forse perché eravamo giovani, e ci sentivamo tutti artisti o intellettuali in erba… ma ci sembrava che ogni volta che passavamo da Beaubourg avessimo imparato qualcosa. Ci fossimo nutriti.
La prima volta che ho visitato il Centre Pompidou ero bambina, in vacanza a Parigi con i miei genitori. Il forum era pieno di ragazzi che leggevano, ascoltavano musica o chiacchieravano, seduti su strane panchine dalla forma sinuosa. Semplicemente stavano. I ricordi sono spesso balordi, e chissà quando questo in particolare si è trasformato in sensazione, ma ogni volta che ci ripenso mi piace immaginare che anche per loro Beaubourg fosse un posto accogliente, in cui la cultura faceva del suo meglio per essere accessibile davvero a tutti. Senza idealismi, certo, e nonostante tutti gli errori, i difetti, i tentennamenti: in fin dei conti Beaubourg era anche “un barcone più o meno ingestibile”* come lo aveva definito Libé all’apertura. Che sia proprio stata la sua ingestibilità a farlo navigare sulle acque della cultura per cinquant’anni?
Certo, chiaramente Beaubourg non ha cambiato il mondo. Anzi: è il mondo che è cambiato intorno. E oggi, in cui l’apertura agli altri non è più una virtù, in cui i fondi pubblici per l’arte e per la cultura si riducono al lumicino anche in Francia, come in Italia, la chiusura di Beaubourg – seppure temporanea – ci fa un po’ più male.
Rimettiti in forma, Beaubourg: cinque anni sono tanti, e chissà che mondo ci sarà qua fuori quando riaprirai. Ma noi ti aspettiamo.