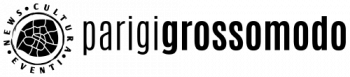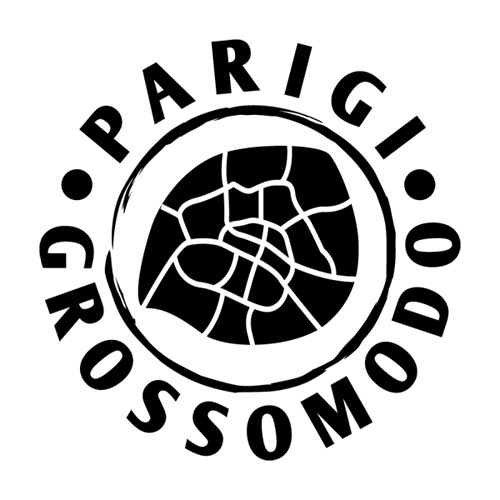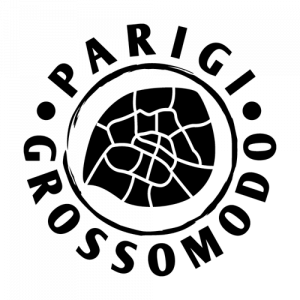Italiani che fanno cose è una nuova rubrica di Parigi Grossomodo, nella quale vi facciamo incontrare delle e degli italiani in Francia attraverso il loro percorso. Chef, imprenditori, artisti, scrittori… con ognuno di loro approfondiremo l’itinerario che li ha portati in Francia e il loro rapporto col loro nuovo paese di residenza, attraverso un’intervista senza filtri, nella quale prendiamo il tempo di conoscerli veramente. Perché siamo convinte che se si prende il tempo di approfondire qualunque argomento è interessante e ognuno di noi ha qualcosa da insegnare!
Italiani che fanno cose è una rubrica per conoscerli e conoscerci, noi, italiani in Francia, al di là dei cliché e delle statistiche e al di là dei diversi percorsi che ci hanno portati qui.
 Stefano de Carli è un cuoco italiano attualmente in chef residency al ristorante Mokoloco, in pieno cuore di Charonne. Dal quartiere Prati di Roma all’undicesimo arrondissement di Parigi, Stefano ci ha raccontato il suo percorso, fatto di tenacia e passione e costellato di incontri essenziali che lo hanno aiutato a scegliere la sua strada. Abbiamo parlato del suo rapporto con la cucina italiana e con la cucina francese, della realtà del mestiere di chef, di cui si dà spesso un’immagine un po’ troppo idealizzata… ma soprattutto abbiamo parlato di cucina!
Stefano de Carli è un cuoco italiano attualmente in chef residency al ristorante Mokoloco, in pieno cuore di Charonne. Dal quartiere Prati di Roma all’undicesimo arrondissement di Parigi, Stefano ci ha raccontato il suo percorso, fatto di tenacia e passione e costellato di incontri essenziali che lo hanno aiutato a scegliere la sua strada. Abbiamo parlato del suo rapporto con la cucina italiana e con la cucina francese, della realtà del mestiere di chef, di cui si dà spesso un’immagine un po’ troppo idealizzata… ma soprattutto abbiamo parlato di cucina!
Pronti a farvi venire l’acquolina in bocca? Seguiteci durante questa intervista allora!
PG: Ciao Stefano, per iniziare ti va di presentarti?
S: Ciao Pargi Grossomodo! Mi chiamo Stefano de Carli, vivo a Parigi da sette anni e sono un cuoco: lavoro nella ristorazione da 15 anni e in cucina da 11. Attualmente sto facendo una chef residency presso il ristorante Mokoloco che durerà fino alla fine di novembre, per un totale di tre mesi circa di pop up. Si tratta della mia terza esperienza da chef: la prima è stata al Grand Pigalle Hotel sotto la consulenza di Giovanni Passerini, mentre la seconda è durata una manciata di mesi all’Hotel Bachaumont. In seguito sono stato chef di cucina di Passerini… O almeno, questo era quanto diceva il mio contratto, ma nei fatti sono stato il secondo di Giovanni a tutti gli effetti!
PG: Perdona l’ignoranza, ma cosa è una chef residency?
S: A Parigi esistono diversi ristoranti in cui gli chef cambiano regolarmente, per dei periodi più o meno brevi. Si tratta di un’opportunità per i giovani chef di farsi conoscere, ma anche di testare le proprie ricette. I clienti, dal canto loro, hanno la possibilità di scoprire sempre cucine diverse.
PG: Dunque, più di un decennio di lavoro in cucina, tra l’Italia e la Francia. Da dove ti è venuta questa passione?
S: Tutto è cominciato quando avevo 17 anni e andavo ancora a scuola. Era estate e con la mia famiglia e la famiglia del mio migliore amico eravamo partiti in vacanza in un villaggio turistico, dove avevamo fatto amicizia con un sacco di altri ragazzini della nostra età. C’era quindi la voglia di rivederli, e ovviamente quella di rivedere le varie ragazzine con cui c’era stato qualche intrallazzo… Insomma, volevo tornare là in vacanza! Per farlo, però, servivano i soldi: fu allora che i miei genitori mi dissero: “vai a lavorare e pagati la vacanza!” Ho iniziato a girare per il mio quartiere, Prati, chiedendo in tutti i ristoranti se cercassero dei camerieri. Ed è così che ho iniziato a lavorare come cameriere al Benji, un bar in Piazza Mazzini. Per me è stato come un vero e proprio colpo di fulmine: ho scoperto un mondo che mi ha subito appassionato!
PG: E come sei passato dalla sala alla cucina?
S: Visto che imparavo in fretta, in capo a un annetto mi occupavo già dell’organizzazione degli eventi privati. Ho scoperto in quel momento di avere un carattere ambizioso e così ho iniziato a interessarmi a due figure del mondo della ristorazione: il barman e lo chef.
PG: E così hai deciso di passare dall’altra parte della barricata…
S: Nel frattempo ero diventato amico dello chef, con cui condividevo la passione per il metal. Presi così la decisione di lasciare l’università – mi ero iscritto a lingue perché ho sempre amato l’inglese – e di iniziare a lavorare in cucina. Il ristorante ha chiuso qualche mese dopo, ma con la liquidazione ho potuto pagarmi un corso di cucina, che mi ha permesso di imparare le basi teoriche del mestiere.
PG: Basi teoriche che hai potuto mettere in pratica durante le tue esperienze di lavoro successive. Esperienze che, immagino, ti abbiano portato a conoscere persone che ti hanno ispirato e dato voglia di continuare in questa direzione…
S: Moltissime. La prima persona che mi viene in mente è lo chef Antonio Martucci, col quale ho lavorato per quattro anni in un hotel cinque stelle lusso. Antonio mi ha insegnato molto, era uno chef fortissimo e sono convinto che in Francia avrebbe avuto un enorme successo. In cucina i ritmi sono altissimi e l’unico modo per uscirne è fare squadra con i propri colleghi: con Antonio eravamo molto legati.
PG: Parliamo del tuo arrivo a Parigi: cosa ti ha portato a lasciare Roma per la Ville Lumière?
S: Tra le mie esperienze professionali a Roma ho lavorato da Settembrini con lo chef Luigi Nastri. Là avevo stretto amicizia con due ragazzi, Flavio e Federico, con i quali siamo sempre rimasti in contatto. Per questo, quando – nel 2015 – Federico ha iniziato a lavorare al ristorante Heimat, a Palais Royal, e mi ha proposto di venire a Parigi come sous-chef. Non me lo sono fatto ripetere due volte, anche perché gli stipendi in Francia nella ristorazione sono decisamente più alti che in Italia… Anche se all’epoca non sapevo quanto i costi della vita a Parigi fossero elevati!
È stato l’inizio della mia carriera in Francia: non è stato facile, perché i ritmi nella cucina gastronomica in Francia sono altissimi e comunicare in francese per me a quei tempi non era così immediato… Son comunque riuscito ad entrare al Grand Pigalle Hotel [hotel dell’Experimental Group, gigante della ristorazione e del turismo in Francia e non solo ndr.] ed è stata un’esperienza veramente importante. Nove mesi dopo mi hanno proposto di lavorare come chef per la cucina del ristorante Bachaumont, gestito anch’esso dall’Experimental Group.
Di una cosa sono certo: in Italia non mi sarebbe mai stata data quest’opportunità a un’età così giovane! Purtroppo una volta iniziato a lavorare al Bachaumont ho sentito una grande pressione: ho tenuto duro il più possibile, ma ho vissuto un burn out importante e ho scelto di mettere fine a questa esperienza, che è stata comunque molto formatrice. È stato a quel momento che sono entrato a lavorare con Giovanni Passerini: un rapporto umano bellissimo, una sfida professionale eccitante e soprattutto l’avventura gastronomica più interessante della mia carriera!
PG: Giovanni è un po’ il tuo padre spirituale?
S: Sicuramente. Come cuoco ci sono due figure che considero fondamentali per la mia formazione: Antonio Martucci e Giovanni Passerini. Da lui ho imparato tanto: l’importanza dei brodi, l’importanza dei fondi… E l’attenzione al minimo dettaglio!
PG: Per l’appunto, perché non parliamo un po’ di cucina? Come descriveresti la tua?
S: Mi bastano poche parole. La definirei zozza e bona… ma senza mai perdere l’eleganza. Io non mi definisco un gourmet… ma un golosone! Mi piacciono gli hamburger, la pizza, i tacos… insomma le zozzerie per dirlo come diciamo a Roma. Nella mia vita ho avuto la fortuna di lavorare con degli chef di altissimo livello che mi hanno insegnato l’importanza dell’equilibrio in un piatto. Un piatto può essere goloso, zozzo, “sporco”… ma non bisogna esagerare. Diciamo che l’esperienza con dei grandi chef mi ha permesso di limare la mia naturale tendenza all’esagerazione!
PG. Un esempio della tua cucina?
 S. Certo, prendiamo uno dei miei piatti signature, sul menù di Mokoloco fin dal primo giorno: si tratta di un raviolo circolare chiuso sui lati, come un culurgiones sardo. Per me questo piatto mi rappresenta: visto che amo le carni brasate e le carni bollite l’ho voluto farcire di genovese di maiale; la genovese è una salsa campana a base di vitello e cipolle che ho imparato a fare da Passerini. L’idea di fare un raviolo solo mi ha fatto pensare all’Asia, e mi ha ricordato che Antonio Martucci amava lavorare sulle influenze asiatiche nei suoi piatti. Il maiale, quindi, è infuso con la citronella, per ricordare un po’ la tradizione asiatica. Per finire, il raviolo è condito da una vichyssoise fatta di fondo di maiale, latte di mandorla e perlata con l’olio di levistico. Un’insalatina di levistico e mandorle posata sul raviolo termina la ricetta.
S. Certo, prendiamo uno dei miei piatti signature, sul menù di Mokoloco fin dal primo giorno: si tratta di un raviolo circolare chiuso sui lati, come un culurgiones sardo. Per me questo piatto mi rappresenta: visto che amo le carni brasate e le carni bollite l’ho voluto farcire di genovese di maiale; la genovese è una salsa campana a base di vitello e cipolle che ho imparato a fare da Passerini. L’idea di fare un raviolo solo mi ha fatto pensare all’Asia, e mi ha ricordato che Antonio Martucci amava lavorare sulle influenze asiatiche nei suoi piatti. Il maiale, quindi, è infuso con la citronella, per ricordare un po’ la tradizione asiatica. Per finire, il raviolo è condito da una vichyssoise fatta di fondo di maiale, latte di mandorla e perlata con l’olio di levistico. Un’insalatina di levistico e mandorle posata sul raviolo termina la ricetta.
Per me si tratta di un piatto a 360°, che richiama le influenze di Martucci e di Passerini… E che mi ricorda anche un piatto che Bottura presentava nel suo libro “Vieni in Italia con me”, e che si chiamava: Come mangiare cotechino e lenticchie 365 giorni l’anno. Era un raviolo unico, molto minimal, ma poi dentro c’era la tradizione. Esattamente come dicevo prima: zozzo, bono… ma elegante!
PG. La tradizione, appunto… Come hai imparato a far convivere tradizione culinaria italiana e francese?
S. Può sembrare una battuta… Ma ho imparato più della tradizione gastronomica italiana a Parigi con Passerini che in Italia. Pensa che la mia prima trippa alla romana io l’ho cucinata a Parigi! Quello che apprezzo molto della ristorazione francese è la grande conoscenza delle materie prime. Un’altra cosa che ho imparato qui e che mi piace molto è il fatto di cambiare il menù molto spesso. A Roma ero abituato a menù che cambiano ogni tre mesi, su  base stagionale… Qua volendo puoi cambiarlo anche tutti i giorni!
base stagionale… Qua volendo puoi cambiarlo anche tutti i giorni!
Infine, è qui a Parigi che ho imparato le basi di quello che si chiama surf’n’turf, ovvero il fatto di mescolare pietanze di mare e di terra in uno stesso piatto. Si tratta di qualcosa che apprezzo molto e che cerco di mettere in pratica: uno dei piatti che ho sviluppato da Mokoloco e di cui vado molto fiero è una terrina di trippa con una maionese all’ostrica, fungo shitaké sottaceto e salicornia. Si tratta di un vero connubio mare e terra, qualcosa che in Italia mi sembrava inconcepibile… Anche se a pensarci bene siamo tutti figli del vitello tonnato!
PG. Viviamo in un’epoca storica in cui gli chef più famosi sono considerati vere e proprie star. Mi sembra di capire che dal tuo punto di vista questa immagine glamour sia un po’ fastidiosa. Cosa significa per te essere uno chef?
S. Io cerco di fare attenzione alla coerenza di quello che faccio e che dico con quello che sono. Quando mi presento, quindi, tendo a dire che sono un cuoco e faccio lo chef. Non che sono uno chef. Essere uno chef per me è avere una conoscenza quasi illimitata delle ricette e delle cucine mondiali… per me è qualcosa di veramente raro. Poi, oggettivamente, i media hanno fatto passare quest’immagine dello chef come di un artista un po’ pazzoide che butta giù ricette bislacche sull’ispirazione del momento… E no, non funziona così! È un lavoro, è sacrificio, io ci ho messo anni per improvvisare una ricetta alle 10 di mattina per il servizio di mezzogiorno.
Martucci diceva sempre che le regole vanno conosciute bene per poterle infrangere!
PG. E nel concreto del lavoro in cucina cosa significa fare lo chef?
S. Prima di tutto vuol dire essere un po’ masochista, perché vuol dire aver voglia di lavorare tanto, tantissimo, con degli orari pesantissimi e un grosso stress sulla riuscita del piatto. È faticoso sia a livello fisico che mentale. Perché essere lo chef di un ristorante significa prima di tutto essere un leader, caricare la squadra ed essere un esempio per loro.
Devi essere un po’ psicologo e anche un po’ economista, per imparare a bilanciare i prezzi sul menù. E ovviamente devi soprattutto essere creativo!
PG. Qual è la più grande soddisfazione della tua carriera?
S. Me ne vengono in mente due! La prima è stata lavorare da Passerini, perché col tempo ho sentito che Giovanni si fidava di me, mi lasciava da solo in cucina… E la fiducia che mi è stata data da un grande chef per me è stata veramente importante. E la seconda è l’esperienza qui a Mokoloco. Le persone che passano a farti i complimenti dopo aver mangiato i tuoi piatti, la tua cucina… Alla fine lavoriamo per le persone, i loro complimenti sono la cosa che mi tocca di più!
PG. Ultima domanda: tra un mesetto termina la tua esperienza qui da Mokoloco. Programmi per il futuro?
S. Molti, ma te li riassumo in due punti: aprire un ristorante mio e riuscire a trovare un po’ più di tempo libero fuori dalla cucina!