 “Lo spirito di una lingua si manifesta chiaramente soprattutto nelle parole intraducibili” sosteneva la scrittrice austriaca Marie von Ebner-Eschenbach (e si può star sicuri che da buona germanofona di intraducibilità ne doveva sapere un bel po’ più di noi). Il problema è che quello che affascina linguisti e filologi in erba diventa una vera croce per i semplici emigranti che, nonostante la conoscenza della lingua straniera, si scontrano prima o poi con questa amara verità: certe parole ed espressioni non sono traducibili. Pensateci un attimo, quante volte nel bel mezzo di una conversazione coi locali vi siete resi conto che quella cosa che vi faceva tanto ridere a telefono con vostro cugino riportata in francese non strapperà al vostro interlocutore che un sorriso di compatimento? E quante volte è stato necessario un lungo giro di parole per definire qualcosa che nella vostra lingua natale è una sola e semplice parola?
“Lo spirito di una lingua si manifesta chiaramente soprattutto nelle parole intraducibili” sosteneva la scrittrice austriaca Marie von Ebner-Eschenbach (e si può star sicuri che da buona germanofona di intraducibilità ne doveva sapere un bel po’ più di noi). Il problema è che quello che affascina linguisti e filologi in erba diventa una vera croce per i semplici emigranti che, nonostante la conoscenza della lingua straniera, si scontrano prima o poi con questa amara verità: certe parole ed espressioni non sono traducibili. Pensateci un attimo, quante volte nel bel mezzo di una conversazione coi locali vi siete resi conto che quella cosa che vi faceva tanto ridere a telefono con vostro cugino riportata in francese non strapperà al vostro interlocutore che un sorriso di compatimento? E quante volte è stato necessario un lungo giro di parole per definire qualcosa che nella vostra lingua natale è una sola e semplice parola?
Non parlo qui di nomi che indicano un oggetto concreto, e che non si possono tradurre perché l’oggetto in questione all’estero non lo conoscono (grande classico delle discussioni di gastronomia: la panna è panna, non crème liquide!). Parlo proprio di quelle sfumature sottili, quasi impalpabili, che danno al discorso tutto un altro senso, che permettono la battuta, alleggeriscono il discorso, rimettono le cose in prospettiva. E che – tra l’altro – ci rendono più simpatici.
Questo fine settimana ero a pranzo a casa di un buon bevitore e fine cinefilo: al momento dell’aperitivo il soggetto in questione nomina il cocktail Martini. Come resistere alla tentazione di citare il mitico “agitato, non mescolato” di jamesbondiana memoria? Soltanto che la mia cultura in merito si è formata grazie alle cassette registrate da Retequattro, per cui mi lancio impavida in un maccheronico “agité, pas mélangé” che ha – ovviamente – suscitato lo sganasciamento del mio ospite. Perché, e ve lo dico per evitarvi la stessa figura di merda, in francese 007 ordina un Martini, certo, ma “au shaker, pas à la cuillère”. Però – potete giustamente obiettare – per casi come questo in fin dei conti basta guardare il film in francese e il problema è risolto. Vero (eccetto il fatto che materialmente non avrete mai il tempo di riguardare in francese tutti i film cult della vostra gioventù, ma è un’altra storia) però come la mettiamo con i film italiani? Come la mettiamo con la “cagata pazzesca” di Fantozzi o con la “supercazzola” di Amici miei? Provate un po’ voi a tradurre “come se fosse antani, la supercazzola con scappellamento”, poi ne riparliamo!
Comunque sia; chiuso il capitolo cinema, anche perché se fossero solo le citazioni a essere difficoltose, non sarebbe poi un problema così grande: il fatto è che ci sono decine di parole di uso comune che in francese semplicemente non esistono e senza le quali ci rendiamo conto che non possiamo vivere. Vi faccio qualche esempio: l’amico vi chiede “tu pars en vacance cet été?” ma tu al mare non ci puoi andare perché ti hanno fatto un contratto di esclavage à temps indéterminé (sono sicura che esiste) e hai maturato solo 15 minuti di ferie. Il problema è che in francese non puoi rispondere “Magari”. Non vi affannate a cercarlo. Non esiste. Perché il magari è un peut-être che vorrei che fosse vero. Ci accompagna nel mondo della speranza-ultima-a-morire: “magari” è una parola fatalista, calda, mediterranea. Sorella di persino e addirittura, che – non è un caso – si rivelano anch’esse tenacemente intraducibili, tanto come avverbi quanto come risposte enfatiche.
Il francese non si augura, non esprime stupore, non sottolinea la straordinarietà di un evento. Il francese constata, suppone o sa. E lo fa in modo serio e misurato. Persino un po’ borioso, tanto che – lo abbiamo già detto – spesso nella nostra testa si forma un gigantesco “anche meno” che però – l’amara delusione- non si può tradurre (così come l’amico “ma anche no”, che tanto dispiaceva al buon Severgnini ma che se ben usato si rivela di grande utilità). Stessa ragione per cui le espressioni – volgari certo, ma oh quanto pregnanti! – sticazzi e mecojoni resistono a qualunque tentativo di adattamento alla lingua straniera, permanendo immutate, oasi di italianità nella conversazione con gli autoctoni.
Si rivelano di impossibile traduzione gran parte delle espressioni che esprimono il dubbio, la speranza, lo stupore, ma anche alcuni modi di dire provenienti dall’universo personale, intimo, dei sentimenti: un amico ti ringrazia di avergli fatto un favore: “ma figurati!” rispondi tu. “Figurati” è più forte di un “prego”: è quasi indignazione per aver ringraziato per così poco. “Mi raccomando” introduce una richiesta, certo, ma la prende a cuore. Per non parlare dell’intraducibile per eccellenza “Ti voglio bene”.
Tempo fa girava su internet un bel video nella quale si presentavano otto parole intraducibili in altrettante lingue; per l’italiano era stata scelta abbiocco, ma la lista potrebbe continuare: scaricabarile, secchione, giramento… Un capitolo a parte meritano le bestemmie: in francese il concetto di bestemmia non esiste, tanto che non esiste neppure un termine preciso per definirle. Da buoni laici i francesi, interrogati a questo soggetto, vi risponderanno che solo un popolo profondamente religioso quale il nostro (che ci piaccia o no) poteva esprimere tanta fantasia nell’inventare l’enorme ventaglio di bestemmie che esiste nella penisola.
Per finire, ma entriamo nel campo del dialettale e dello slang, tante espressioni che usiamo quotidianamente non sono proprio concepibili in un’altra lingua, spesso perché il retroterra culturale da cui nascono è prettamente italico: buonanotte al secchio, bona cisi, che storia, alla cazzo di cane, ciaone… Eh sì, perché io ci ho pure provato a spiegare il senso di ciaone ad un francofono… Ma quando, ingenuamente, mi ha chiesto “c’est un peu comme si on disait grand salut?” non ho potuto trattenermi da un italianissimo “Sì, vabbè, ciao! Anzi, ciaone!”
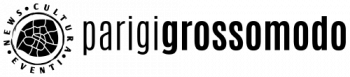
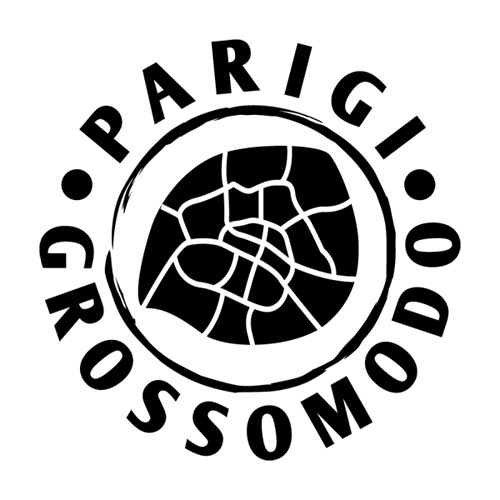







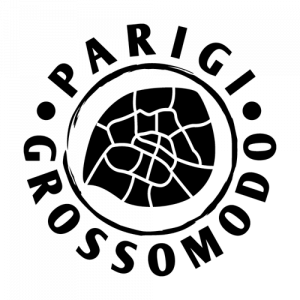
I commenti sono chiusi.